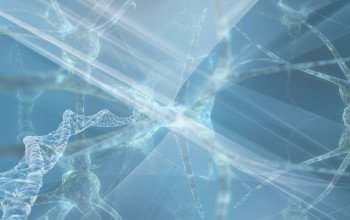In occasione della Giornata mondiale dedicata alla malattia, si discute del ruolo dell’editing genomico per formulare una terapia potenzialmente risolutiva
Nel film “Blu profondo” una dottoressa svolge ricerche sui cervelli di squalo mako per scovare una terapia in grado di riaccendere le sinapsi nei pazienti affetti da malattia di Alzheimer. Mettendo da parte le fantascientifiche evoluzioni della pellicola rimane fermo il concetto che una patologia neurodegenerativa come quella debba esser affrontata ricorrendo a ogni spunto che la ricerca scientifica sia in grado di offrire. L’editing del genoma - e in particolare la tecnologia CRISPR - rappresenta l’ultima straordinaria occasione per accelerare l’acquisizione di conoscenze, lavorando su modelli cellulari avanzati, e arrivare quanto prima a una terapia mirata. E quale migliore momento potrebbe esserci per rivedere i traguardi delle ricerche con CRISPR se non la Giornata mondiale dell’Alzheimer?
Istituita nel 1994 per volere dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dell’Alzheimer's Disease International (ADI), la Giornata mondiale dell’Alzheimer - che si celebra ogni anno il 21 settembre - si pone l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sulla malattia, promuovendo la nascita di iniziative dedicate alla diffusione di informazioni aggiornate su questa terribile patologia del sistema nervoso. Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità la malattia di Alzheimer rappresenta la forma di demenza più comune nella popolazione di età superiore ai 65 anni. Nel mondo essa affligge più di 55 milioni di persone e, complice l’innalzamento dell’età media e il progressivo invecchiamento della popolazione, si stima che nei prossimi 25 anni i numeri saliranno ulteriormente.
L’Alzheimer è un disturbo neurodegenerativo progressivo e irreversibile sul quale la medicina sta concentrando molta attenzione dal momento che la stessa patogenesi della malattia non è stata ancora compresa in ogni sua sfumatura: le attuali conoscenze attribuiscono un ruolo centrale alla presenza di aggregati della proteina tau e ai depositi di beta-amiloide nel cervello. Quest’ultima, in particolare, è stata oggetto di una interessante ricerca che vede protagonista Crispr-Cas9, la tecnologia di correzione del DNA più nota e sfruttata nei laboratori di ricerca di tutto il mondo.
LA CORREZIONE DELLA PROTEINA BETA-AMILOIDE
Durante la scorsa edizione dell’Alzheimer’s Association International Conference (AAIC), svoltasi ad Amsterdam lo scorso luglio, sono state presentate due ricerche che prendono di mira elementi ritenuti responsabili dell’innesco dei meccanismi sfocianti nel deterioramento cognitivo tipico della malattia. Il primo di essi punta a ridurre proprio la produzione della proteina beta-amiloide.
Come descritto in un’interessante review pubblicata sull’International Journal of Molecular Sciences da un gruppo di ricerca siciliano, l’accumulo di beta-amiloide è direttamente coinvolto nella formazione delle placche tipiche dell’Alzheimer. In particolare, in una ridotta frazione di persone l’Alzheimer insorge su base ereditaria, con mutazioni che riguardano il gene APP, il quale codifica per un precursore della proteina amiloide. Su questo gene si sono soffermati Brent Aulston e i suoi colleghi del laboratorio di Subhojit Roy presso l’Università della California a San Diego (Stati Uniti). Essi hanno realizzato un modello murino della malattia di Alzheimer e, usando CRISPR, hanno cercato di correggere il gene in modo tale da ridurre la quantità di proteina beta amiloide.
Tuttavia, secondo quanto fanno notare i ricercatori italiani, mentre la maggior parte delle mutazioni che interessano il gene APP è direttamente collegata all’insorgenza dell’Alzheimer, alcune mutazioni hanno un ruolo protettivo, pertanto l’utilizzo di CRISPR non deve solo ridurre la quantità di proteina patologica ma anche aumentare il livello di quei prodotti benefici in grado di preservare i neuroni. Un approccio a cui si sono dedicati anche scienziati giapponesi e che Aulston sta perfezionando, con l’aiuto del sistema di editing per correggere una sequenza all’estremità C- terminale del gene APP: ciò favorisce un meccanismo di taglio che predilige la formazione di prodotti con funzione protettiva anziché tossica.
Come si legge nell’abstract di presentazione della ricerca all’AAIC, gli scienziati statunitensi hanno seguito varie strade per testare la sicurezza e l’efficacia del loro metodo osservando una riduzione delle placche di beta-amiloide e dei marcatori associati all’infiammazione cerebrale, in presenza di un aumento dei prodotti neuroprotettivi ottenuti da APP e della correzione dei deficit comportamentali e funzionali del sistema nervoso dei topolini. Infine, il metodo messo punto a San Diego non ha provocato effetti collaterali indesiderati, suggerendo la sicurezza dell’approccio con CRISPR. “Questi risultati giustificano l’avvio di futuri studi volti a portare l’editing di APP con CRISPR nella sperimentazione umana”, afferma Aulston. In effetti, altri gruppi di ricerca hanno concentrato il loro interesse sul taglio e sulla modifica di APP, confermandone l’utilità sia su modelli in vivo che in vitro.
APOE-e4: UN GENE CHE PREDISPONE LO SVILUPPO DELL’ALZHEIMER
L’utilizzo dell’editing del genoma per districare il nodo patogenetico della malattia di Alzheimer e individuare nuove soluzioni terapeutiche sta portando i ricercatori a puntare su diverse strategie. Boris Kantor e Ornit Chiba-Falek, del Center for Advanced Genomic Technologies presso la Duke University di Durham, hanno rivolto la loro attenzione al gene APOE-e4: si tratta di uno dei maggiori fattori di rischio associati alle forme sporadiche di Alzheimer e viene espresso dagli astrociti (cellule del sistema nervoso centrale). Tuttavia, la presenza di questa specifica isoforma dell’apolipoproteina E (APOE) non è solo legata allo sviluppo della malattia di Alzheimer in quanto più indirettamente correlata ai processi neurodegenerativi e di danno neurologico. Altri ricercatori avevano già tentato di usare Crispr-Cas9 per correggere APOE-e4 in APOE3r ma Kantor e Chiba-Falek hanno usato una piattaforma di correzione di loro invenzione, progettata in maniera specifica per colpire APOEe4, riducendone l’espressione in modelli di neuroni ottenuti da cellule staminali pluripotenti indotte (iPSC) e in organoidi: in entrambi i casi è stata osservata un abbassamento di livelli di mRNA e della proteina associata. Inoltre, essi sono riusciti a replicare tale risultato in modelli murini della malattia, confermando l’utilità e l’efficacia della loro terapia epigenomica mirata ad APOE.
Si tratta di un risultato di notevole interesse, non solo per le prospettive terapeutiche ma anche per la possibilità che offre di realizzare un modello attendibile della malattia di Alzheimer, cosa non facile dal momento che in molte versioni precedenti del modello di malattia non si riusciva a instaurare nel cervello dei topolini un meccanismo neurodegenerativo tale da replicare quello delle cellule umane. Su questo fronte d’indagine le aspettative riversate sulla tecnologia CRISPR sono molto alte. “I nostri risultati sono incredibilmente eccitanti”, afferma Kantor. “Forniscono una prova di concetto a sostegno del nostro approccio come strategia ad alto potenziale per trattare e forse anche prevenire la malattia di Alzheimer, che attualmente non ha una cura”.
E SUL FRONTE FARMACOLOGICO?
Questi studi - condotti su modelli cellulari e animali, non ancora giunti alla fase clinica di sperimentazione - sono un’iniezione di speranza per pazienti e familiari giacché consentono di mettere meglio a fuoco i meccanismi biologici sottostanti la genesi della patologia e, a partire da ciò, offrono un’indicazione per lo sviluppo di terapie specifiche. Il fatto che siano rivolti a bersagli differenti non può che consolidare la fiducia di chi spera che, in futuro, possano esistere più alternative terapeutiche da combinare insieme per arrestare l’evoluzione di forme di demenza come l’Alzheimer.
E la combinazione di più trattamenti non esclude i farmaci tradizionali, fra cui gli anticorpi monoclonali che, al momento, costituiscono l’opportunità di trattamento più concreta per questa devastante malattia.
Sempre all’AAIC, infatti, son stati presentati i primi risultati dell’utilizzo di donanemab, l’anticorpo monoclonale di Ely Lilly che prende a bersaglio una componente specifica della proteina beta-amiloide associata alla placche tipiche dell’Alzheimer. Pubblicati sulla rivista JAMA, i risultati dello studio di Fase III TRAILBLAZER-ALZ 2 confermano l’efficacia del farmaco nel rallentare il declino cognitivo sia in pazienti con la forma precoce di malattia che in quelli con la forma avanzata.
I risultati fatti riscontrare da donanemab - non solo in termini di efficacia ma anche di sicurezza - sono un significativo passo avanti ma c’è ancora molta strada da fare e, per quel che riguarda le terapie avanzate, sarà necessario vincere le attuali limitazioni costituite dal rischio di provocare tagli indesiderati in punti aspecifici del DNA. Tuttavia queste ricerche sono i piccoli ma inequivocabili segnali che una rivoluzione terapeutica è in atto e, in un non fantascientifico futuro, potrebbe portare al traguardo che la comunità dei malati Alzheimer spera di tagliare da sempre.