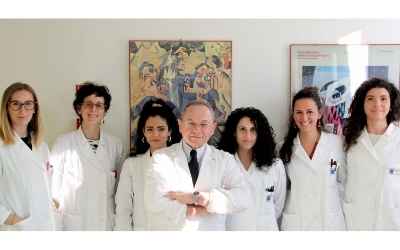Un gruppo di ricerca italiano ha messo a punto una strategia che sfrutta le cellule CIK “guidate” da un anticorpo monoclonale per combattere forme resistenti di linfoma diffuso a grandi cellule B
Da ormai diversi anni le terapie CAR-T sono divenute il simbolo della lotta a leucemie e linfomi refrattari o resistenti alle terapie convenzionali. Pubblicazioni di studi e presentazioni ai congressi internazionali sono un flusso continuo di nuovi promettenti dati riguardanti il loro impiego contro il mieloma multiplo, certi tumori solidi o anche il linfoma non-Hodgkin. Purtroppo però la via delle CAR-T non è sempre precorribile, bisogna quindi escogitare strategie alternative. Una di queste si basa sulla combinazione di cellule CIK e anticorpi monoclonali ed è stata messa a punto da un team di ricercatori dell’Università di Padova. Ce ne parla il prof. Antonio Rosato che ha guidato lo studio.
LE CELLULE CIK
Uno studio pubblicato a luglio su Journal for ImmunoTherapy of Cancer i ricercatori dell’Università di Padova hanno descritto un interessante protocollo per il trattamento dei linfomi a cellule B utilizzando una terapia che combina l’uso di anticorpi monoclonali anti-CD20 e le cellule CIK. Ma cosa sono esattamente le cellule CIK? Esse costituiscono un interessante settore di ricerca, che si aggiunge a quello delle CAR-T, per lo sviluppo di prodotti destinati a combattere in maniera mirata alcune forme tumorali resistenti alle terapie standard.
“Le CIK sono cellule citotossiche killer indotte da citochine e rappresentano l’evoluzione delle cellule LAK (Lymphokine Activated Killers) ideate negli anni Ottanta all’interno dei laboratori guidati da Steven Rosenberg all’NIH”, spiega il prof. Antonio Rosato, del Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche dell’Università di Padova, che ha coordinato la ricerca italiana. “Esse si ricavano in maniera piuttosto semplice dal sangue periferico di individui sani o malati, dopo aver isolato le cellule mononucleate da incubare con dosi appropriate di interferone-gamma per un periodo di tempo di 24 ore. Successivamente, le CIK vengono attivate con un anticorpo, come OKT-3, e mantenute per diverse settimane in coltura. In questo modo, si ottiene una popolazione di cellule che è all’interfaccia tra il sistema immunitario innato e quello adattativo, dal momento che le CIK condividono alcuni marcatori - specialmente il CD56 - delle cellule Natural Killer, e altri della componente adattativa, in particolare il CD3 tipico dei linfociti T”.
In poche parole le CIK sono una popolazione ibrida (con caratteristiche attribuibili alle cellule NK e ai linfociti T) che per il riconoscimento cellulare ricorre a recettori diversi dal classico T-cell receptor dei linfociti T e appartenenti al gruppo delle cellule NK (usano soprattutto NKG2D); perciò non essendo specifiche per una data neoplasia le CIK possiedono la capacità di riconoscere vari tipi di tumori, solidi o ematologici, in modo particolare quando questi esprimono i ligandi naturali di tali recettori presenti sulla loro superficie e su quella delle cellule NK. “Le CIK sono state classificate come Prodotti Medicinali di Terapie Avanzate (ATMP) e sono state studiate in contesti neoplastici molto diversi su un database internazionale composto da oltre 10 mila pazienti”, prosegue Rosato. “Hanno il vantaggio di poter esser generate in maniera pratica e sono relativamente economiche da produrre anche in grande quantità ma, soprattutto, hanno un livello di alloreattività minimo e ciò significa che, se trasferite da un donatore sano a un paziente, non generano la cosiddetta malattia da trapianto contro l’ospite (GVHD)”.
UN ANTICORPO FA DA “GPS” PER GUIDARE LE CIK CONTRO I LINFOMI
Le CIK si inseriscono bene in quel filone di ricerca che, specialmente negli ultimi anni, si è orientato sulla specificità di riconoscimento del tumore, in maniera tale da mirare dritte alle cellule neoplastiche bersaglio e ridurre così gli effetti “off-target”. “In un precedente studio pubblicato sulla rivista Oncoimmunology avevamo descritto una particolarità delle CIK, cioè l’espressione in percentuale variabile dell’antigene CD16, una molecola tipica delle cellule NK e legata al fenomeno della citotossicità mediata da cellule dipendente da anticorpi (ADCC, Antibody-Dependent Cellular Cytotoxicity)”, precisa Rosato. “In tal caso l’anticorpo fa da ponte e si lega in modo specifico alla cellula tumorale o infettata da virus, lasciando il proprio frammento FC libero di interagire con CD16 e trasdurre un segnale di attivazione delle cellule CIK o NK. A questo punto, le cellule attivate scaricano il loro comparto granulare generando una reazioni di citotossicità nei confronti della cellula invasiva”.
Per tale ragione, i ricercatori guidati dal prof. Rosato e dalla dott.ssa Roberta Sommaggio, dell’Istituto Oncologico Veneto, hanno pensato di far ricorso ad anticorpi normalmente usati in clinica, fra cui herceptin e cetuximab, per ‘indirizzare’ in maniera precisa le cellule CIK contro il tumore. Infatti, come spiegato in un altro articolo pubblicato lo scorso anno sempre sulla rivista Oncoimmunology, il perno di questo approccio è identificare un bersaglio sulla cellula tumorale che possa esser preso di mira da un anticorpo monoclonale e aggiungere alla ricetta una popolazione cellulare di “assalto”, come le CIK. L’anticorpo funge da sistema di riconoscimento delle cellule tumorali e le CIK possono così attaccarle e distruggerle.
LO STUDIO PRECLINICO SUI LINFOMI NON-HODGKIN
“Abbiamo dimostrato la validità di questo approccio in laboratorio su cellule tumorali umane di ovaio, mammella e prostata e, più recentemente, anche in ambito ematologico”, aggiunge Rosato. “Il nostro ultimo lavoro verte ai linfomi non-Hodgkin, un gruppo di tumori la cui incidenza è in continuo aumento e che comprende numerose ed eterogenee varianti, ognuna con diversa presentazione clinica e altrettanto differente evoluzione e risposta al trattamento. Grazie all’aggiunta di un anticorpo monoclonale anti-CD20 le nostre cellule CIK, prodotte a partire da donatori sani, sono riuscite ad uccidere le cellule tumorali in vitro. Ma il loro effetto si è confermato anche in un modello murino su cellule tumorali in vivo. In aggiunta, abbiamo testato la combinazione di cellule CIK e anticorpo monoclonale anche contro le stesse cellule del paziente (approccio autologo, N.d.R.), ottenendo conferma del risultato osservato”.
Oltre a ciò, per rendere più efficace l’impiego delle CIK in pazienti in cui le cellule tumorali erano già circolanti nell’organismo, i ricercatori patavini sono ricorsi a un anticorpo bispecifico, in grado cioè di legare i linfociti T da una parte e i linfociti B colpiti dal tumore dall’altra. Producendo in vitro le CIK da campioni di sangue di un paziente in queste condizioni, nella coltura essi hanno trovato sia le CIK che le cellule del tumore ma aggiungendo l’anticorpo bispecifico le CIK si sono espanse uccidendo tutte le cellule tumorali. Tanto che, nell’arco di 2-3 settimane, i ricercatori hanno avuto a disposizione una popolazione di cellule CIK adatta all’uso nei pazienti. E tutto ciò senza alcuna modificazione genetica dei linfociti e senza la necessità di ricorrere a sofisticati centri specializzati per la produzione.
I PROSSIMI PASSI: PUNTARE ALLA SPERIMENTAZIONE CLINICA
“Da diversi anni abbiamo iniziato una collaborazione con i colleghi di Vicenza, specialmente il dott. Marco Ruggeri, direttore della U.O.C di Ematologia dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza, a cui afferisce il Laboratorio per le Terapie Cellulari Avanzate, unica GMP Facility attualmente autorizzata in Veneto per lo sviluppo di ATMP”, prosegue Rosato. “Abbiamo a lungo discusso con il dott. Giuseppe Astori, direttore del Laboratorio per le Terapie Cellulari Avanzate, e ci siamo confrontati per arrivare ad allestire e testare il protocollo di sviluppo e produzione delle CIK, secondo gli standard GMP, in modo tale che la procedura potesse essere trasferita al più presto alla GMP Facility. Siamo convinti che la multidisciplinarietà sia un bene imprescindibile per questo genere di studi”.
Infatti, i dati finora raccolti sono più che sufficienti per proporre il passaggio successivo, ovvero lo sviluppo clinico, e gli scienziati stanno lavorando per scrivere un Investigational Medicinal Product Dossier (IMPD) da sottomettere alle autorità regolatorie per iniziare a trattare i primi pazienti nell’ambito di uno studio clinico. Servono fondi adeguati per dare avvio al trial ma il processo di ricerca non si ferma ed entro i primi mesi del 2022 sarà possibile conoscere meglio i termini per la traslabilità clinica del protocollo.
Le ‘CIK ad attivazione anticorpale’ potrebbero costituire una concreta alternativa per quei pazienti in recidiva e con forme di tumore plurirefrattarie ai trattamenti per cui le CAR-T non siano una strategia percorribile. Non sono poche le persone che, per varie ragioni, oggi si trovano in questa situazione e non hanno modo di accedere alle terapie a base di cellule CART. Per loro le CIK potrebbero costituire una speranza in più, dal momento che possono essere prodotte in miliardi di unità a partire da una minima quantità di sangue.
“Quello che abbiamo messo a punto è un approccio sicuro ed efficace, grazie a cui sarà possibile vincere le limitazioni legate all’età (ad oggi, in Italia le terapie CAR-T non vengono somministrate a pazienti al di sopra dei 70 anni, N.d.R.) e avere un’importante ricaduta anche per i tumori solidi”, conclude Rosato. “Infatti, le CIK hanno una miglior capacità dei linfociti T di penetrare il tumore e, grazie alla molecola di anticorpo-guida, presentano un plus di direzionamento antigene-anticorpo. Per questo stiamo valutando di avviare uno studio su pazienti con tumore mammario sensibile all’anticorpo monoclonale per le quali non siano disponibili ulteriori opzioni terapeutiche”.