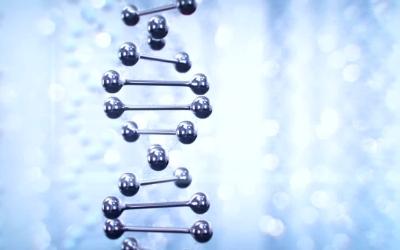Prof. Vincenzo Leuzzi (Università Sapienza di Roma): “È un salto di qualità per coloro che sono affetti dalla presentazione grave della malattia”
Pochi giorni fa il Comitato per i Medicinali per Uso Umano (CHMP) dell’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha espresso il suo benestare alla commercializzazione di una terapia genica in grado di cambiare la qualità di vita dei pazienti affetti dal deficit di decarbossilasi degli L-aminoacidi aromatici (deficit di AADC). Si tratta di una malattia genetica ultra-rara, di cui si contano poco più di 200 casi in tutto il mondo e che può presentarsi in forma grave con una diminuzione del tono muscolare, riduzione dei movimenti volontari, crisi oculogire e disfunzioni del sistema nervoso autonomo. A spiegare il valore di questa innovativa terapia è il prof. Vincenzo Leuzzi, Ordinario di Neuropsichiatria Infantile all’Università Sapienza di Roma, precisando come il deficit di AADC sia una realtà che in pochi conoscono dettagliatamente.
UNA MALATTIA POCO CONOSCIUTA
Dietro una nomenclatura così difficile da tenere a memora si nasconde una patologia ultra-rara la cui origine risale alle mutazioni nel gene DDC che codifica per l’enzima decarbossilasi degli L-aminoacidi aromatici (AADC). “La conseguenza di tali mutazioni è il deficit dell’ultima tappa di sintesi di dopamina e serotonina, due neuromediatori essenziali per il corretto funzionamento sia del sistema nervoso centrale che periferico”, afferma il prof. Leuzzi. “L’inadeguata sintesi di questi neuromediatori non comporta soltanto un’importante alterazione della connettività cerebrale, ma, emergendo precocemente dopo la nascita, anche una grave compromissione dello sviluppo di importanti funzioni neurologiche e cognitive”. Descritta per la prima volta 30 anni fa, la malattia ha un esordio solitamente precoce, con un grave ritardo delle acquisizioni psicomotorie, ipotonia muscolare e particolari deviazioni toniche dello sguardo (crisi oculogire). Non ha un decorso progressivo ma stabile nel tempo, determinando tuttavia una grave o gravissima disabilità.
“Sulla base della frequenza allelica delle varianti patogenetiche note, si stima una frequenza di un caso ogni 90-120 mila nati, superiore a quella risultante dai casi noti: ciò suggerisce che la malattia sia sottodiagnosticata”, aggiunge Leuzzi. “Infatti, la diagnosi è legata ovviamente alla conoscenza della malattia da parte del medico che ne identifica i sintomi clinici ma è anche possibile che il fenotipo di presentazione della malattia includa forme meno gravi e meno tipiche meno suggestive”.
Senza un’accurata formazione sulla patologia è difficile poterne coltivare il sospetto clinico. “Una volta considerata la possibilità di trovarsi di fronte al deficit di AADC, la diagnosi non è più complessa”, prosegue Leuzzi. “Fino a qualche tempo fa la conferma diagnostica si basava sul dosaggio di metaboliti della serotonina e della dopamina nel liquido cefalo-rachidiano. La procedura era invasiva e l’esame appannaggio di pochi laboratori italiani. Da pochi anni a questa parte è stato visto che un metabolita presente anche nel sangue - la metildopa (3-OMD) - si è dimostrato un ottimo marker periferico per la malattia, potendo essere dosato anche su poche gocce di sangue essiccato su carta bibula”. Questa semplice procedura è ora candidata per un possibile screening neonatale della malattia, rendendo la diagnosi disponibile nell’arco di poche ore. Rimane il problema della conoscenza di una patologia complessa, la cui gestione è affidata a centri specializzati.
UNA TERAPIA GENICA PER I CASI GRAVI
Tra le sette terapie avanzate che dovrebbero essere approvate da parte dell’EMA nel corso del 2022 c’è anche eladocagene exuparvovec, una terapia genica sviluppata dall’azienda PTC Therapeutics per contrastare il deficit di AADC. Il parere favorevole espresso dal CHMP è una conquista significativa per questa terapia, che ha ricevuto la designazione di farmaco orfano e che è indicata per i pazienti con deficit di AADC di età superiore ai 18 mesi. “Lo sviluppo della terapia genica è stato effettuato da ricercatori di Taiwan, area geografica ove la malattia ha una frequenza di circa 1 caso ogni 30 mila con presentazioni di notevole gravità”, chiarisce Leuzzi. “Questi pazienti sono poco responsivi alle attuali terapie farmacologiche la cui relativa efficacia riguarda circa il 25-30% di loro”.
“Eladocagene exuparvovec è una terapia genica in vivo, somministrata con un’iniezione intracerebrale direttamente nel putamen che consente alle cellule di quest’area del cervello di acquisire la capacità di sintetizzare la dopamina, la quale si sostituisce a quella normalmente fornita dai neuroni dopaminergici del sistema nigrostriatale”, spiega Leuzzi. “L’esito del trattamento si è rivelato molto significativo ovviamente in relazione alla gravità iniziale e probabilmente all’età del paziente. Il miglioramento ha riguardato non solo la funzione motoria, ma anche quella cognitiva generando un complessivo miglioramento clinico del paziente. La terapia genica costituisce dunque un indubbio salto di qualità per chi ha la forma grave della malattia”.
Sebbene destinata ad allargare il ventaglio terapeutico per questa patologia, eladocagene exuparvovec non sarà applicabile a tutti i malati ma solamente a quanti soffrono della forma grave del deficit di AADC. “Fra i criteri di selezione per il trattamento c’è l’assenza del controllo del capo, il che indica una grave compromissione motoria”, conclude Leuzzi. “I dati oggi a disposizione mostrano come la terapia sia in grado di modificare la storia naturale della malattia, ma al momento le indicazioni di utilizzo sono ristrette a pazienti che non hanno alternative terapeutiche”. In Italia sono circa 4-5 i pazienti a poter beneficare di questa terapia - che sarà erogata presso il Policlinico Umberto I di Roma, identificato come centro di riferimento per il deficit di AADC.
A questo punto, per l’ufficializzazione dell’approvazione di eladocagene exuparvovec, bisogna aspettare che la Commissione Europea ratifichi l'autorizzazione alla commercializzazione. Il tempo stimato è di circa due mesi.