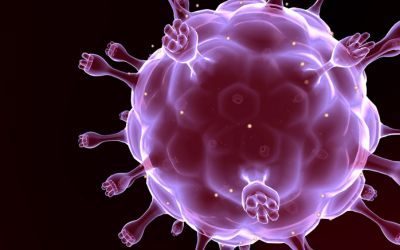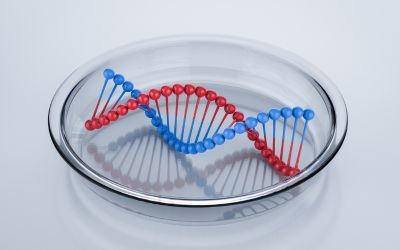Terapia genica
Trattare le malattie mirando alle basi genetiche
COME FUNZIONA LA TERAPIA GENICA?
Tra le diverse terapie avanzate e di precisione, la terapia genica è una delle prime ad essere state ideate e ha l’obiettivo di trattare una patologia mirando direttamente alle sue basi genetiche. Il concetto base di questa strategia terapeutica è di fornire all’organismo una copia corretta del gene difettoso o un altro gene che possa compensarne il malfunzionamento nelle cellule colpite dalla malattia.
Esistono due principali modalità di somministrazione per la terapia genica:
- in vivo: il “gene terapeutico” viene somministrato direttamente nell’organismo del paziente, mediante un’iniezione per via locale (organo bersaglio) o per via sistemica (nella circolazione sanguigna);
- ex vivo: la correzione avviene all’esterno dell’organismo del paziente. Infatti, le cellule bersaglio vengono prelevate dal paziente, modificate geneticamente, e reintrodotte nel paziente stesso.
Per veicolare il “gene terapeutico” all’interno delle cellule o dell’organismo si utilizzano generalmente dei vettori virali: ad oggi i più utilizzati sono i vettori virali adeno-associati (AAV).
Il potenziale della terapia genica è di enorme portata poiché potrebbe rappresentare una cura per tutta una serie di gravissime malattie per cui oggi non esistono valide opzioni terapeutiche o che richiedono terapie croniche. Ad oggi la ricerca nell’ambito della terapia genica spazia dalle malattie genetiche, in particolar modo quelle rare, al cancro, passando per le malattie autoimmuni e le malattie infettive.
Il concetto di terapia genica nasce alla fine degli anni ‘80 con le nuove tecniche del DNA ricombinante che permettono di costruire pezzi di DNA contenenti sequenze geniche desiderate. Ma è solo negli ultimi anni, con il sequenziamento del genoma e l’avanzare delle biotecnologie, che si sono cominciati a vedere i primi importanti risultati nelle sperimentazioni sull’uomo e le prime terapie geniche autorizzate dall’European Medicines Agency (EMA) in Europa e della Food and Drug Administration (FDA) negli Stati Uniti. In questo ambito l’Italia ha una posizione di eccellenza a livello internazionale: sono diverse le terapie avanzate frutto di ricerche all'avanguardia "made in Italy".
Terapia enzimatica sostitutiva e trapianto di cellule staminali ematopoietiche, le due opzioni terapeutiche oggi disponibili per le MPS, hanno dei limiti che la terapia genica può superare
Le mucopolisaccaridosi (MPS) sono un gruppo di disturbi genetici ereditari legati all'accumulo di glicosaminoglicani nei lisosomi. Queste malattie sono caratterizzate da manifestazioni multisistemiche come anomalie scheletriche, cardiache e neurologiche. Attualmente, i trattamenti includono la terapia enzimatica sostitutiva e il trapianto di cellule staminali ematopoietiche, che mostrano però limitazioni significative. La terapia genica emerge come una strategia promettente per superare questi ostacoli, consentendo l'espressione a lungo termine del gene terapeutico nei tessuti colpiti. Una review, firmata da due ricercatori italiani - Nicola Brunetti-Pierri e Alessandro Rossi - e pubblicata su The Journal of Inherited Metabolic Disease, esplora i recenti sviluppi nella terapia genica per le MPS, con particolare attenzione agli approcci ex vivo e in vivo e ai progressi clinici per i vari sottotipi.
- Di: Rachele Mazzaracca
Il Bambino Gesù sta selezionando pazienti con la forma più grave della malattia, le loro cellule saranno utilizzate per testare in laboratorio una nuova terapia genica. Ce ne parla la dott.ssa May El Hachem
Una malattia genetica rara, con alcune forme gravemente invalidanti, per cui ad oggi non esiste ancora una cura risolutiva: l’epidermolisi bollosa (EB) è una condizione altamente impattante sulla salute e sulla qualità di vita delle persone che ne sono affette e delle loro famiglie. Le forme intermedie, ma soprattutto gravi, dell’epidermolisi bollosa distrofica recessiva, sono quelle con le conseguenze più devastanti per l’organismo e sono le protagoniste dello studio preclinico avviato all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (OPBG) - il cui Investigatore Principale è il professor Franco Locatelli, responsabile di Oncoematologia, Terapia Cellulare, Terapie Geniche e Trapianto Emopoietico del centro - con l’obiettivo di poter sviluppare una nuova terapia genica sperimentale. Osservatorio Terapie Avanzate ha intervistato la dottoressa May El Hachem, responsabile della dermatologia dell’Ospedale e co-responsabile del progetto.
- Di: Rachele Mazzaracca
Eugenio Montini (SR-Tiget): “Grazie alla comprensione delle dinamiche del successo della ricostituzione ematopoietica, lo studio apre le porte a trattamenti più personalizzati”
Uno studio, recentemente pubblicato su Nature dal team di ricerca dell’Istituto San Raffaele Telethon per la Terapia Genica (SR-Tiget) di Milano, ha rivelato nuovi dettagli sulla sicurezza e sull’efficacia a lungo termine della terapia genica con cellule staminali ematopoietiche modificate tramite vettori lentivirali (LV). Si tratta dello studio più completo mai condotto su questa tecnica, che promette di trasformare il trattamento di malattie genetiche rare. L’analisi ha preso in considerazione 53 pazienti sottoposti a terapia genica per tre diverse patologie: la leucodistrofia metacromatica (MLD), la sindrome di Wiskott-Aldrich (WAS) e la beta-talassemia, con un follow-up fino a 8 anni. Ne abbiamo parlato con il dott. Eugenio Montini, group leader in SR-Tiget che ha diretto lo studio.
- Di: Rachele Mazzaracca
I ricercatori del Tigem di Pozzuoli hanno valutato l’affidabilità del loro trattamento sperimentale a diversi anni dalla somministrazione in quattro piccoli pazienti
Una terapia genica in sperimentazione per una malattia rara può essere paragonata a una navetta spaziale che sulla carta è in grado di esplorare i lati più nascosti dell’universo: genera un forte entusiasmo iniziale e raccoglie consenso e partecipazione, ma bisogna accertarsi che nella pratica continui a funzionare bene per periodi prolungati di tempo al fine di garantire la sicurezza degli astronauti e raggiungere tutti gli obiettivi fissati. Per questa ragione, in uno studio clinico pubblicato sulla rivista Med-Cell Press gli scienziati dell’Istituto Telethon di Genetica e Medicina (Tigem), coordinati dal professor Nicola Brunetti-Pierri, hanno valutato sia l’efficacia che la sicurezza di una terapia genica sperimentale per la mucopolisaccaridosi di tipo VI (MPS VI) a distanza di almeno 3 anni dalla somministrazione.
- Di: Redazione
Sono stati confermati i risultati positivi a lungo termine del trattamento con elivaldogene autotemcel, ma sono stati rilevati alcuni casi di tumore del sangue
A inizio ottobre sono stati pubblicati sul The New England Journal of Medicine (NJEM) gli esiti a lungo termine dei pazienti trattati con la terapia genica elivaldogene autotemcel (eli-cel, nome commerciale Skysona), evidenziando l’efficacia ma anche alcuni problemi di sicurezza. I dati pubblicati mostrano che 7 dei 67 bambini che hanno ricevuto la terapia genica sviluppata da bluebird bio per l’adrenoleucodistrofia cerebrale (CALD), nel contesto di studi clinici, hanno poi sviluppato tumori del sangue. Di questi sette casi, quattro sono stati sviluppati da giugno 2022, quando tre casi di cancro avevano già messo in allerta la Food and Drug Administration (FDA) statunitense, che ha poi approvato la terapia in seguito a ulteriori valutazioni. I ricercatori temono che nei prossimi anni altri pazienti potrebbero sviluppare il cancro e per questo li stanno monitorando con regolari prelievi di sangue.
- Di: Rachele Mazzaracca
Una ricerca condotta dall’IRCCS Besta di Milano mira a sviluppare una terapia farmacologica neonatale e una strategia terapeutica fetale per la rara malattia mitocondriale
Un ambizioso progetto: così si può definire lo studio coordinato da Dario Brunetti, biotecnologo e ricercatore del Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità dell'Università Statale di Milano e principal investigator presso l'Istituto neurologico Carlo Besta, che vede come protagonista la sindrome di Leigh e la possibilità di testare alcuni farmaci già in uso per altre patologie (il cosiddetto drug repurpusing) nel periodo postnatale, ma anche quella - ancora più temeraria - di correggere il difetto genetico che causa la malattia agendo direttamente sul feto. Ne abbiamo parlato con il dott. Brunetti e con il prof. Nicola Persico, chirurgo fetale del Policlinico di Milano e docente di Ostetricia e ginecologia del Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità UniMi, insieme hanno sviluppato il protocollo per la terapia genica sperimentale in utero per questa malattia mitocondriale.
- Di: Rachele Mazzaracca
Agenda
News da CRISPeR MANIA
a cura di Anna Meldolesi