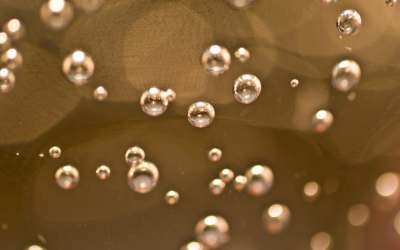Terapia genica
Trattare le malattie mirando alle basi genetiche
COME FUNZIONA LA TERAPIA GENICA?
Tra le diverse terapie avanzate e di precisione, la terapia genica è una delle prime ad essere state ideate e ha l’obiettivo di trattare una patologia mirando direttamente alle sue basi genetiche. Il concetto base di questa strategia terapeutica è di fornire all’organismo una copia corretta del gene difettoso o un altro gene che possa compensarne il malfunzionamento nelle cellule colpite dalla malattia.
Esistono due principali modalità di somministrazione per la terapia genica:
- in vivo: il “gene terapeutico” viene somministrato direttamente nell’organismo del paziente, mediante un’iniezione per via locale (organo bersaglio) o per via sistemica (nella circolazione sanguigna);
- ex vivo: la correzione avviene all’esterno dell’organismo del paziente. Infatti, le cellule bersaglio vengono prelevate dal paziente, modificate geneticamente, e reintrodotte nel paziente stesso.
Per veicolare il “gene terapeutico” all’interno delle cellule o dell’organismo si utilizzano generalmente dei vettori virali: ad oggi i più utilizzati sono i vettori virali adeno-associati (AAV).
Il potenziale della terapia genica è di enorme portata poiché potrebbe rappresentare una cura per tutta una serie di gravissime malattie per cui oggi non esistono valide opzioni terapeutiche o che richiedono terapie croniche. Ad oggi la ricerca nell’ambito della terapia genica spazia dalle malattie genetiche, in particolar modo quelle rare, al cancro, passando per le malattie autoimmuni e le malattie infettive.
Il concetto di terapia genica nasce alla fine degli anni ‘80 con le nuove tecniche del DNA ricombinante che permettono di costruire pezzi di DNA contenenti sequenze geniche desiderate. Ma è solo negli ultimi anni, con il sequenziamento del genoma e l’avanzare delle biotecnologie, che si sono cominciati a vedere i primi importanti risultati nelle sperimentazioni sull’uomo e le prime terapie geniche autorizzate dall’European Medicines Agency (EMA) in Europa e della Food and Drug Administration (FDA) negli Stati Uniti. In questo ambito l’Italia ha una posizione di eccellenza a livello internazionale: sono diverse le terapie avanzate frutto di ricerche all'avanguardia "made in Italy".
Queste piccole vescicole di grasso possono trasportare terapie innovative nelle cellule bersaglio e il loro profilo di tollerabilità è migliore di quello dei vettori virali o delle nanoparticelle sintetiche
La storia degli esosomi ricorda quella del DNA non codificante, a lungo chiamato “junk DNA”: entrambi all’inizio sono stati scambiati per qualcos’altro. Il junk DNA non è affatto spazzatura e gli esosomi, vescicole di grasso inizialmente scambiate per residui cellulari o scarti, costituiscono un sofisticato sistema di comunicazione, dei “messaggi in bottiglia” che le cellule sane (ma anche quelle malate) scambiano continuamente, tra di loro e con l’esterno. Oggi i ricercatori stanno imparando a usare gli esosomi come vettori per trasportare proteine e geni terapeutici all’interno delle cellule. Un articolo pubblicato su Nature illustra passato e futuro della ricerca sugli esosomi e le loro potenzialità in campo terapeutico e diagnostico.
- Di: Erika Salvatori
Sono stati pubblicati i dati iniziali dello studio clinico di Fase III per la valutazione di delandistrogene moxeparvovec e l’EMA ha dato l’ok all’uso di una misura di valutazione digitale all’interno dei trial
A fine ottobre sono stati condivisi i risultati relativi alla prima parte dello studio di Fase III EMBARK sulla terapia genica delandistrogene moxeparvovec (nome commerciale Elevidys) per il trattamento della distrofia muscolare di Duchenne (DMD). Pur non essendo stato raggiunto l’obiettivo primario, quelli secondari hanno evidenziato una differenza statisticamente significativa nei bambini trattati rispetti a quelli a cui è stato somministrato il placebo. Inoltre, durante l’estate, l’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) ha riconosciuto per la prima volta la possibilità di utilizzare una innovativa misura di valutazione digitale chiamata SV95C (Stride Celocity 95th Centile) come obiettivo primario in studi clinici su pazienti DMD deambulanti a partire dai 4 anni di età.
- Di: Rachele Mazzaracca
Sono sei i pazienti coinvolti nel trial di Fase I/II per valutare la sicurezza e l’efficacia della strategia sperimentale CTNS-RD-04 per il trattamento della malattia da accumulo lisosomiale
Dopo aver ricevuto il via libera dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense per procedere con gli studi sugli esseri umani alla fine del 2018, il trial clinico “Stem Cell Gene Therapy for Cystinosis”, che ha l’obiettivo di valutare una terapia genica per il trattamento della cistinosi, è stato avviato durante l’estate del 2019 ed è tuttora in corso. Una malattia genetica rara che, come tante altre, è ancora orfana di terapia: trovare un’opzione terapeutica in grado di rispondere ai bisogni dei pazienti affetti da cistinosi risulta quindi fondamentale. Il gruppo di ricerca che sta conducendo lo studio lavora presso la University of California sotto la guida di Stéphanie Cherqui, anche autrice di un recente articolo sul tema pubblicato su médecine/sciences.
- Di: Rachele Mazzaracca
Due approcci sono in fase preclinica, per il terzo - ideato per la sordità autosomica recessiva legata al gene OTOF - è stato avviato uno studio clinico multicentrico di Fase I/II
Le sordità sono un campo di studio in cui la medicina ha compiuto notevoli progressi, pur se pongono ai ricercatori ancora sfide complesse, sia in chiave diagnostica che terapeutica. Lo dimostra l’ampio e variegato substrato genetico delle forme sindromiche e non sindromiche da cui sono emerse alcune mutazioni che gli scienziati hanno preso in considerazione per lo sviluppo di nuove forme di trattamento, fra le quali figura la terapia genica. In questo panorama, Decibel Therapeutics - biotech oggi assorbita da Regneron - ha messo in cantiere tre programmi di terapia genica per i disturbi ereditari dell’udito, uno dei quali è già arrivato alle fasi cliniche di sperimentazione. Ne abbiamo parlato con la dott. ssa Lucia Oriella Piccioni, Responsabile dell’Unità Funzionale della Chirurgia dell’Orecchio e dell’Udito presso l’Ospedale San Raffaele di Milano.
- Di: Enrico Orzes
Prof. Yvàn Torrente (Milano): “Sono in via di sviluppo due strategie terapeutiche dalla diversa tecnologia partendo dal medesimo quesito iniziale: come restituire al muscolo la proteina mancante?”
Al culmine della scorsa estate la notizia dell’avvio di uno studio clinico con una nuova terapia genica destinata al trattamento di una distrofia muscolare dei cingoli è passata sotto relativo silenzio. Il fatto che non sia stata pubblicata la lista dei centri ospedalieri presso cui saranno trattati i pazienti e che la prima somministrazione non sarà eseguita prima di gennaio 2024 non ha contribuito alla diffusione della notizia che, invece, è estremamente significativa nel contesto della ricerca di nuove opzioni di cura per le distrofie dei cingoli. Queste malattie, infatti, continuano a rappresentare un vasto ed eterogeneo insieme di patologie neuromuscolari orfane di trattamenti. Ne abbiamo parlato con il professor Yvàn Torrente, neurologo presso la Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e Direttore della Struttura Semplice di Terapie Cellulari e Geniche del Policlinico di Milano.
- Di: Enrico Orzes
Una delle nuove frontiere di ricerca nell’ambito della terapia genica mira alla sostituzione dei vettori virali con nuove tecnologie che dovrebbero superare i limiti ora esistenti e ridurre i costi
Un articolo dal titolo “Why gene therapies must go virus-free”, pubblicato a giugno su Nature Biotechnology, affronta il tema del superamento dell’utilizzo dei vettori virali per la somministrazione delle terapie geniche. Sebbene i progressi fatti negli ultimi decenni siano stati incredibili e abbiamo permesso di portare sul mercato terapie per malattie precedentemente senza opzioni di trattamento, è indubbio che le terapie geniche siano molto costose e che l’utilizzo dei vettori virali abbia dei limiti. Le aziende biotecnologiche si trovano ora di fronte a una nuova sfida: sostituire i vettori virali con altri approcci, con il fine ultimo di abbassare le spese per lo sviluppo di nuove terapie e superare le problematiche che attualmente sussistono con l’utilizzo dei virus modificati.
- Di: Rachele Mazzaracca
Agenda
News da CRISPeR MANIA
a cura di Anna Meldolesi