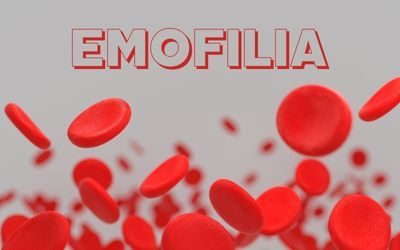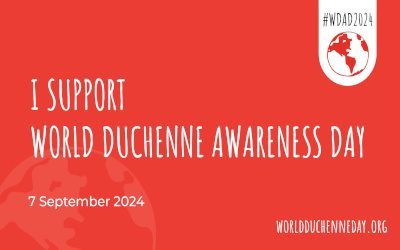Terapia genica
Trattare le malattie mirando alle basi genetiche
COME FUNZIONA LA TERAPIA GENICA?
Tra le diverse terapie avanzate e di precisione, la terapia genica è una delle prime ad essere state ideate e ha l’obiettivo di trattare una patologia mirando direttamente alle sue basi genetiche. Il concetto base di questa strategia terapeutica è di fornire all’organismo una copia corretta del gene difettoso o un altro gene che possa compensarne il malfunzionamento nelle cellule colpite dalla malattia.
Esistono due principali modalità di somministrazione per la terapia genica:
- in vivo: il “gene terapeutico” viene somministrato direttamente nell’organismo del paziente, mediante un’iniezione per via locale (organo bersaglio) o per via sistemica (nella circolazione sanguigna);
- ex vivo: la correzione avviene all’esterno dell’organismo del paziente. Infatti, le cellule bersaglio vengono prelevate dal paziente, modificate geneticamente, e reintrodotte nel paziente stesso.
Per veicolare il “gene terapeutico” all’interno delle cellule o dell’organismo si utilizzano generalmente dei vettori virali: ad oggi i più utilizzati sono i vettori virali adeno-associati (AAV).
Il potenziale della terapia genica è di enorme portata poiché potrebbe rappresentare una cura per tutta una serie di gravissime malattie per cui oggi non esistono valide opzioni terapeutiche o che richiedono terapie croniche. Ad oggi la ricerca nell’ambito della terapia genica spazia dalle malattie genetiche, in particolar modo quelle rare, al cancro, passando per le malattie autoimmuni e le malattie infettive.
Il concetto di terapia genica nasce alla fine degli anni ‘80 con le nuove tecniche del DNA ricombinante che permettono di costruire pezzi di DNA contenenti sequenze geniche desiderate. Ma è solo negli ultimi anni, con il sequenziamento del genoma e l’avanzare delle biotecnologie, che si sono cominciati a vedere i primi importanti risultati nelle sperimentazioni sull’uomo e le prime terapie geniche autorizzate dall’European Medicines Agency (EMA) in Europa e della Food and Drug Administration (FDA) negli Stati Uniti. In questo ambito l’Italia ha una posizione di eccellenza a livello internazionale: sono diverse le terapie avanzate frutto di ricerche all'avanguardia "made in Italy".
Alcune caratteristiche dell’emofilia hanno reso questa malattia un target perfetto per la terapia genica, con importanti investimenti nella ricerca di una soluzione a lungo termine
L’emofilia A e B sono difetti della coagulazione, che provocano sanguinamenti spontanei in diverse sedi del corpo, la cui causa risiede in una mutazione che si trasmette da una generazione all’altra e provoca la riduzione o l’assenza di un fattore di coagulazione. A seconda del tipo di errore sul DNA, gli effetti sull’organismo possono essere più o meno gravi e richiedere uno specifico approccio terapeutico. Pur essendoci stati dei progressi a livello farmacologico, nei casi più seri il rischio emorragico resta e il trattamento continuativo è necessario, specialmente nel caso di sanguinamenti acuti o interventi chirurgici. La terapia genica rappresenta quindi una possibile soluzione a lungo termine, essendo in grado di indurre la produzione del fattore mancante anche per anni dopo la somministrazione. Ma quante e quali sono le terapie geniche per l’emofilia autorizzate o in fase avanzata di sperimentazione?
- Di: Rachele Mazzaracca
Il trattamento sperimentale, messo a punto al Tigem di Pozzuoli, è per la rara malattia ereditaria dell’occhio che nella sindrome di Usher è associata a sordità
Dopo l’esperienza di successo con la terapia genica voretigene neparvovec, un altro traguardo per la Clinica Oculistica dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” di Napoli, diretta dalla professoressa Francesca Simonelli: per la prima volta al mondo è stata somministrata una terapia genica sperimentale per una rara malattia ereditaria dell’occhio associata a sordità, la sindrome di Usher di tipo 1B (USH1B). La tecnologia alla base del trattamento è stata sviluppata nei laboratori dell’Istituto Telethon di genetica e medicina (Tigem) di Pozzuoli, sotto la supervisione del neodirettore prof. Alberto Auricchio. L’innovatività risiede nella capacità di questa piattaforma di poter trasportare geni di grosse dimensioni, un limite ben noto della terapia genica classica. Ne abbiamo parlato con la prof.ssa Simonelli (guarda la videointervista qui).
- Di: Rachele Mazzaracca
Un team di ricerca dell'Indiana University School of Medicine ha messo a punto una strategia innovativa per ripristinare la versione completa della distrofina
Sabato 7 settembre si celebrerà l’undicesima Giornata Mondiale di sensibilizzazione sulla distrofia muscolare di Duchenne (World Duchenne Awareness Day, WDAD). Uno dei temi più sentiti dalla comunità è ovviamente quello di una cura, che purtroppo ancora non è stata trovata: la terapia genica è da anni al centro dell’interesse di chi cerca una soluzione terapeutica per la distrofia muscolare di Duchenne, con qualche traguardo raggiunto ma senza reali rivoluzioni. L’approccio più studiato – e già autorizzato come trattamento negli Stati Uniti – si basa sulla terapia genica per la produzione di una forma ridotta, ma funzionale, della distrofina. Uno studio pubblicato a luglio su Nature Communication, punta, invece, a ripristinare la versione completa della proteina.
- Di: Rachele Mazzaracca
È stata somministrata, all’interno di uno studio clinico condotto in Canada, a un bambino di 4 anni affetto da una malattia ultra-rara che provoca la degenerazione del tratto corticospinale
L’articolo pubblicato a fine giugno sulle pagine della rivista Nature Medicine non racconta solo di una terapia genica sviluppata in maniera personalizzata, in tempi brevi e dal costo di quasi quattro milioni di dollari, per uno dei circa cento bambini al mondo affetti da una gravissima malattia neurodegenerativa - la paraplegia spastica ereditaria di tipo 50 - ma accende una lampadina sulle opportunità e sulle criticità legate allo sviluppo di trattamenti innovativi destinati alla cura di malattie ultra-rare (di cui avevamo già parlato anche qui). Nell’arco di tre anni, infatti, i ricercatori sono arrivati a disporre di un farmaco sperimentale tagliato su misura sulle caratteristiche cliniche del giovane. Ciononostante, affinché il modello sia replicabile, bisognerà trovare soluzioni a degli interrogativi ancora aperti.
- Di: Enrico Orzes
Già disponibile in Francia, Austria, Danimarca e Regno Unito: nel Vecchio Continente etranacogene dezaparvovec inizia a cambiare la vita dei pazienti con la malattia emorragica
Etranacogene dezaparvovec (nome commerciale Hemgenix) è una terapia genica one-shot prodotta da CSL Behring per il trattamento dell’emofilia B, approvata negli Stati Uniti da novembre 2022 e in Europa a febbraio 2023. Nel corso di questi mesi sono stati quattro i Paesi europei che hanno autorizzato il rimborso della terapia avanzata: il primo è stato la Francia, seguito dall’Austria e poi, a giugno, dalla Danimarca. Recentemente etranacogene dezaparvovec è stato autorizzato al rimborso anche nel Regno Unito grazie al Fondo per i farmaci innovativi del National Health Service (NHS). Ma dietro a tutti questi iter regolatori ci sono anche le storie dei pazienti: Elliott Collins, 34enne dell’Essex (Regno Unito) affetto da emofilia B, ha raccontato la sua esperienza alla BBC.
- Di: Rachele Mazzaracca
Uno dei problemi della terapia genica è il non poter ricevere una seconda dose per il rischio di scatenare una risposta immunitaria pericolosa per l’organismo
Un articolo recentemente pubblicato ha messo sotto i riflettori un problema noto a chi fa ricerca clinica nel settore della terapia genica: la risposta immunitaria ai virus usati come vettori per veicolare il “gene terapeutico” al suo bersaglio. Il numero di approvazioni e di sperimentazioni di terapie geniche sono aumentate nell'ultimo decennio, ma l'impossibilità di somministrare più di una dose limita le applicazioni terapeutiche. Gli effetti di alcuni trattamenti, infatti, si attenuano nel tempo, mentre altri potrebbero aver bisogno di essere somministrate in più dosi per fornire un beneficio significativo. Questo è noto oggi grazie agli studi fatti in questi anni, ricerche che hanno anche permesso di pensare a delle possibili soluzioni al problema.
- Di: Rachele Mazzaracca
Agenda
News da CRISPeR MANIA
a cura di Anna Meldolesi