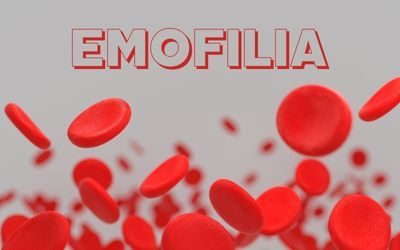Alcune caratteristiche dell’emofilia hanno reso questa malattia un target perfetto per la terapia genica, con importanti investimenti nella ricerca di una soluzione a lungo termine
L’emofilia A e B sono difetti della coagulazione, che provocano sanguinamenti spontanei in diverse sedi del corpo, la cui causa risiede in una mutazione che si trasmette da una generazione all’altra e provoca la riduzione o l’assenza di un fattore di coagulazione. A seconda del tipo di errore sul DNA, gli effetti sull’organismo possono essere più o meno gravi e richiedere uno specifico approccio terapeutico. Pur essendoci stati dei progressi a livello farmacologico, nei casi più seri il rischio emorragico resta e il trattamento continuativo è necessario, specialmente nel caso di sanguinamenti acuti o interventi chirurgici. La terapia genica rappresenta quindi una possibile soluzione a lungo termine, essendo in grado di indurre la produzione del fattore mancante anche per anni dopo la somministrazione. Ma quante e quali sono le terapie geniche per l’emofilia autorizzate o in fase avanzata di sperimentazione?
GENI, VETTORI E STUDI CLINICI
I geni coinvolti nell’emofilia A e B sono, rispettivamente, quello che codifica per il fattore VIII (FVIII) e per il fattore IX (FIX) della coagulazione. Entrambi si trovano sul cromosoma X, motivo per cui la malattia si manifesta solo nei maschi, mentre le femmine sono portatrici sane o, in alcuni casi, presentano sintomi molto lievi. L’emofilia è una candidata ideale per la terapia genica per diversi motivi: in primis perché è una patologia monogenica, ovvero causata dal difetto su un singolo gene, poi perché è sufficiente un’espressione ridotta del fattore di interesse per ottenere evidenti benefici e, infine, per la facilità con cui è possibile monitorare gli effetti a livello del sangue.
La terapia genica per emofilia si avvale generalmente di un vettore virale adenoassociato (AAV), che è in grado di agire efficacemente a livello del fegato e non si integra con il DNA genomico. Nel corso degli anni sono stati testati diversi tipo di AAV, migliorando via via il risultato. Sono più di 50 gli studi clinici interventistici sulla terapia genica per l’emofilia (Fonte: ClinicalTrials.gov), di cui una decina in fase avanzata. Tre prodotti di terapia genica sono già autorizzati dall’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) e uno è già disponibile anche in Italia (scarica la tabella che riassume lo stato delle terapie avanzate approvate in Europa e in Italia QUI).
EMOFILIA A
Il primo studio clinico che ha visto come protagonista l’emofilia A e la terapia genica risale al 2017: valoctocogene roxaparvovec, somministrata in una singola infusione, ha portato buoni risultati nell’aumento dell’attività di FVIII e nella riduzione dei sanguinamenti. Roctavian, nome commerciale della terapia prodotta da Biomarin, è stata autorizzata in Europa nel 2022 e da gennaio di quest’anno è approvata e rimborsata dal Servizio Sanitario italiano per il trattamento di pazienti adulti con emofilia A grave senza inibitore.
Un’altra terapia genica in fase avanzata di studio è dirloctocogene samoparvovec (SPK-8011): prodotta da Spark Therapeutics e di proprietà di Roche, è ora in trial Fase III. Altri studi in corso riguardano ad esempio peboctocogene camaparvovec (Bayer), SPK-8016 (Spark Therapeutics) e giroctocogene fitelparvovec (Pfizer/Sangamo Therapeutics). Lo scorso luglio, queste ultime due aziende hanno riferito che la terapia genica ha raggiunto l'endpoint primario nello studio di Fase III AFFINE e anche gli endpoint secondari, che hanno dimostrato la superiorità rispetto alla semplice profilassi. Sangamo aveva inizialmente sviluppato giroctocogene fitelparvovec con il nome di SB-225 prima di iniziare, nel 2017, la collaborazione con Pfizer. I pazienti che partecipano allo studio AFFINE saranno valutati clinicamente per cinque anni e fino a un totale di 15 anni nell'ambito di uno studio di follow-up a lungo termine.
EMOFILIA B
La prima terapia genica ad essere stata approvata per l'emofilia B è etranacogene dezaparvovec con il nome commerciale Hemgenix. Si tratta di una terapia “one-shot” basata su un vettore AAV la cui ricerca e sviluppo è stata guidata da uniQure che poi, nel 2021, ha concesso in licenza i diritti commerciali globali a CSL Behring. Etranacogene dezaparvovec ha ottenuto l'Autorizzazione all’Immissione in Commercio prima negli Stati Uniti, nel novembre 2022, e dopo qualche mese, a febbraio 2023, in Europa. Gli studi hanno dimostrata l’efficacia nel mantenere elevati i livelli di FIX fino a un anno e mezzo dopo la somministrazione e la quasi totalità dei partecipanti allo studio ha interrotto la profilassi con terapia sostitutiva.
Ad aprile di quest’anno, Pfizer ha ottenuto l'approvazione da parte della Food and Drug Administration (FDA) statunitense per fidanocogene elaparvovec (nome commerciale Beqvez), una terapia genica a base di AAV progettata per il trattamento di adulti affetti da emofilia B da moderata a grave. A luglio la stessa terapia ha ottenuto l'approvazione anche in Europa, dove è commercializzato con il nome di Durveqtix. Anche in questo caso i dati sono stati soddisfacenti e hanno quindi portato a ricevere il via libera dagli enti regolatori. Anche per l'emofilia B sono in corso studi su altri farmaci di terapia genica, come FLT180a (anche noto come verbrinacogene setparvovec, Spur Therapeutics) e BBM-H901 (Belief BioMed).
SICUREZZA E LIMITI DELLA TERAPIA GENICA
Se i benefici di queste terapie sono ormai evidenti, non vanno dimenticati i limiti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza. Il problema più noto è la possibile presenza di anticorpi diretti contro il vettore virale utilizzato, fattore che rende la terapia inefficace. Va poi considerato l’incremento - prevalentemente transitorio - delle transaminasi e il timore dell’integrazione di oncogeni nel DNA dopo la terapia, che può causare neoplasie specialmente a livello del fegato. Anche se ad oggi non è stata dimostrata una correlazione tra terapia genica e neoplasia, l’epatologo è una figura di riferimento fondamentale nel percorso di terapia genica per l’emofilia.
Tra le opzioni in fase di studio per migliorare la terapia genica per l’emofilia c’è anche l’utilizzo di vettori lentivirali, cioè derivati da HIV, che sono spesso usati per le terapie geniche ex-vivo (come ad esempio quelle per alcune immunodeficienze o le terapie CAR-T). Questo permetterebbe di aggirare un limite, dato che sono poche le persone al mondo con infezione da HIV se paragonate al numero di persone che ha incontrato un virus adenoassociato.
Inoltre, per poter prendere la decisione di procedere con la terapia genica in piena consapevolezza vanno tenuti in considerazione anche altri parametri, come il rischio di doversi sottoporre a terapia immunosoppressiva in caso di effetto mancato, oppure quello di trasmissione del transgene alle linee germinali (con conseguente utilizzo di contraccettivi per un certo periodo di tempo dopo la somministrazione), o la necessità di modificare il proprio stile di vita, ad esempio eliminando l’assunzione di alcol nei primi mesi e riducendola nel periodo successivo. La terapia genica, inoltre, è per definizione one-shot: una volta somministrata non si può tornare indietro e annullarne l’effetto. Ancora oggi sono diversi i quesiti che restano senza risposta: quanto durerà l’effetto della terapia? Quanto verrà espresso il fattore VIII o IX? Perché a volte i risultati non sono quelli previsti?
Oggi la terapia genica è – con tutti i suoi limiti e le sue incognite – un’importante opzione terapeutica per i pazienti affetti da emofilia e le approvazioni da parte degli enti regolatori la rendono disponibile per un numero sempre maggiore di persone. Il trattamento va però ponderato sulla base delle condizioni del paziente, così da rendere favorevole il rapporto rischi/benefici.