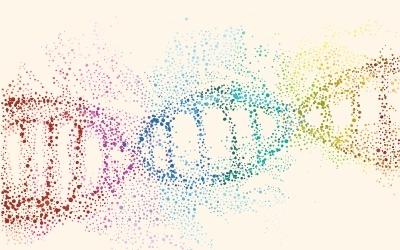Si tratta di un gel contenente un vettore virale in grado di trasportare il gene per ripristinare il collagene difettoso, da applicare direttamente sulle ferite causate dall’epidermolisi bollosa
Il trattamento sperimentale, oggetto dello studio pubblicato a fine marzo su Nature Medicine, prevede la somministrazione topica, direttamente sulle lesioni, di una terapia genica in vivo sotto forma di gel. Questa ricerca, sviluppata dal gruppo di ricerca coordinato da Peter Marinkovich dell’Università di Standford, potrebbe offrire un nuovo approccio per l’epidermolisi bollosa distrofica recessiva. Ne parliamo con Michele De Luca, Direttore del Centro per la Medicina Rigenerativa "Stefano Ferrari" Università di Modena e Reggio Emilia e tra gli ideatori della terapia genica che nel 2015 ha salvato la vita di Hassan, bambino siriano affetto da epidermolisi bollosa giunzionale.
La pelle fragile è la caratteristica più nota dei “bambini farfalla”, cioè di chi è nato affetto da una delle forme di epidermolisi bollosa (EB), malattia genetica rara che provoca bolle e lesioni sull’epidermide e sulle mucose interne anche in seguito a piccoli sfregamenti. Purtroppo, attualmente non esistono trattamenti risolutivi per l’EB, ma la ricerca scientifica continua su più fronti, tra cui le terapie avanzate.
Protagonista dello studio uscito su Nature Medicine è l’epidermolisi bollosa distrofica recessiva (RDEB), una forma di EB causata da mutazioni nel gene COL7A1, che codifica per il collagene VII. “Quest’ultimo, infatti, è responsabile dell’ancoraggio dell’epidermide, lo strato più esterno della pelle, al derma, che si trova al di sotto dell’epidermide”, spiega Michele De Luca. “Nel caso di difetti genetici, il collagene VII non funziona come dovrebbe e i sintomi sono visibili fin dalla nascita: lesioni bollose ricorrenti, infezioni, infiammazione, fibrosi, cicatrici, oltre alla conseguente disabilità fisica. Inoltre, non bisogna dimenticare le lesioni che colpiscono le mucose interne, decisamente più complesse da raggiungere e trattare. Cercare nuove strategie per gestire questa patologia gravemente invalidante è quindi fondamentale”.
L’approccio sviluppato a Standford è molto semplice dal punto di vista della somministrazione: un gel che contiene un virus, modificato in laboratorio per contenere e trasportare il gene terapeutico, viene utilizzato come unguento da applicare localmente sulle lesioni della pelle. Il virus utilizzato è quello dell’herpes simplex di tipo 1 (HSV-1) - noto per causare l’herpes labiale - perché è adatto al trasporto del gene del collagene VII, che è abbastanza grande. Inoltre, questo virus non innesca una risposta efficace da parte del sistema immunitario umano, motivo per cui la maggior parte delle infezioni causate da HSV-1 non guariscono nel corso della vita, ma restano silenti.
Inizialmente il gruppo di ricerca ha dimostrato che il trattamento con il gel permetteva di indurre la produzione di collagene VII in studi preclinici su topi modello e nella pelle di pazienti RDEB. I risultati presentati di recente, invece, riguardano i dati relativi alla sicurezza e all’efficacia di un trial clinico di Fase I/II, controllato con placebo e finanziato dalla Krystal Biotech. La terapia genica in vivo beremagene geperpavec (B-VEC), che può essere applicata ripetutamente, è stata sperimentata su 9 pazienti, che hanno ricevuto B-VEC o placebo, per 12 settimane. Sono state trattate 19 ferite cutanee di diverse dimensioni ma, dato che il vettore usato non è in grado di attraversare le giunzioni strette presenti tra le cellule epiteliali, la terapia può essere applicata solo su lesioni aperte e non a scopo preventivo. Le ferite trattate sono guarite per tre mesi e non sono stati osservati eventi avversi gravi. Dato che nuovi traumi possono causare altre lesioni bollose al di fuori delle ferite precedentemente trattate e che il singolo trattamento non ha effetti a lungo termine, si può immaginare un dosaggio periodico di B-VEC.
Attualmente sono due gli studi clinici in corso su B-VEC, entrambi di Fase III: uno è condotto in doppio cieco e controllato con placebo, della durata di 6 mesi e con 31 partecipanti, mentre l’altro è “open label”, della durata di un anno e mezzo circa e prevede l’arruolamento di 30 persone. Esiste un’altra terapia genica sperimentale per l’epidermolisi bollosa distrofica recessiva – EB-101, attualmente in Fase III in uno studio sovvenzionato da Abeona Therapeutics - che prevede il trasferimento di una copia funzionale del gene COL7A1 nelle cellule epiteliali, che vengono successivamente trapiantate nel paziente sotto forma di lembi per il trattamento delle ferite (ne abbiamo scritto qui). Uno studio simile è in fase di avvio a Modena, presso il gruppo di ricerca coordinato dal prof. De Luca.
“Nel complesso, la terapia genica in vivo somministrata tramite gel è piuttosto attraente, poiché non richiederebbe processi di produzione costosi, complessi e lunghi, né procedure cliniche invasive e potrebbe essere applicata in un ambiente ambulatoriale”, prosegue il professore. “Inoltre, la facilità di applicazione topica della terapia genica in gel potrebbe, in linea di principio, riuscire ad affrontare ferite finora non trattabili e altamente invalidanti che colpiscono le mucose interne o altri siti difficili da raggiungere con altre modalità”.
Gli ostacoli evidenziati, tra cui la necessità di somministrazioni multiple e continuative nel tempo, potrebbero essere superati inserendo in modo permanente il gene nel genoma delle cellule staminali epidermiche. Le colture contenenti cellule staminali epidermiche transgeniche possono essere utilizzate per preparare innesti in grado di ripristinare permanentemente un'epidermide funzionale nei pazienti con EB. Infatti, la terapia combinata ex vivo è stata proposta per affrontare sia la RDEB che la forma giunzionale. Nel caso di Hassan il gruppo di De Luca - in seguito al prelievo di un piccolo lembo di pelle - ha inserito una copia funzionale di LAMB3, gene che codifica per la laminina, nelle cellule staminali della pelle con l’obiettivo di ricostruire un tessuto funzionale e integro. La laminina, infatti, è un’altra proteina fondamentale per ancorare l’epidermide al derma. Le colture di epidermide geneticamente corretta cresciute in laboratorio hanno permesso ai ricercatori di Modena di produrre lembi abbastanza grandi da essere trapiantati per sostituire l’80% di pelle danneggiata, salvando la vita al bambino ormai in condizioni critiche a causa dell’EB giunzionale.
“Il nostro approccio richiede competenze molto specifiche sia per la coltura di cellule staminali sia per l’intervento chirurgico”, conclude De Luca. “Si tratta di procedure costose e complesse che, pur assicurando il ripristino permanente di una epidermide funzionale a lungo termine, hanno delle limitazioni: ad esempio non è possibile raggiungere le mucose o trattare qualsiasi zona del corpo. La terapia genica in vivo potrebbe rivelarsi ideale per il trattamento di lesioni localizzate o in quei siti in cui non si può agire diversamente. I due approcci non devono escludersi a vicenda. La strategia terapeutica d’elezione dovrebbe essere definita in base alla situazione clinica del paziente - che è davvero molto variabile nel caso dell’epidermolisi bollosa - con l’unico obiettivo di migliorare la sua qualità della vita”.