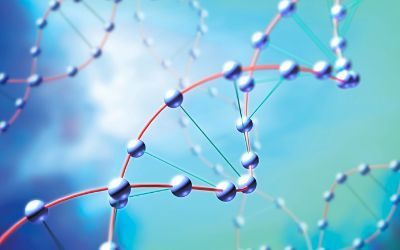I ricercatori dell’Istituto Telethon di Pozzuoli hanno pubblicato gli esiti di uno studio clinico di Fase I/II che confermano la sicurezza e l’efficacia della nuova terapia sperimentale
Poco più di un anno fa dalle parole del prof. Alberto Auricchio, dell’Istituto Telethon di Genetica e Medicina (Tigem) di Pozzuoli, eravamo venuti a conoscenza dell’avvio di uno studio clinico su una terapia genica per la mucopolisaccaridosi di tipo 6 (MPS VI), una malattia anche nota come sindrome di Maroteaux-Lamy, compresa nel vasto insieme delle mucopolisaccaridosi. I risultati preliminari dello studio sono stati pubblicati questo mese sulle pagine della prestigiosa rivista The New England Journal of Medicine e testimoniano l’avanzamento di un cammino di ricerca che si spera potrà proseguire fino all’agognato traguardo di un trattamento efficace per questa rara malattia da accumulo lisosomiale.
Bassa statura, opacità corneale, epato-splenomegalia, ispessimento delle valvole cardiache e malformazioni scheletriche sono alcune delle conseguenze della sindrome di Maroteaux-Lamy, provocata dalla carenza dell’enzima arisulfatasi B (ARSB), necessario per lo smaltimento di un glicosaminoglicano noto come dermatan solfato. La malattia si manifesta sin dall’infanzia e, sebbene sia disponibile una terapia enzimatica sostitutiva, la qualità di vita dei pazienti rimane bassa in quanto gli effetti del trattamento - che deve esser mantenuto per tutta la vita e si realizza con una serie di infusioni da effettuare in ospedale - faticano a raggiungere alcuni degli organi colpiti, tra questi le ossa.
“La terapia genica può superare questi limiti”, afferma Alberto Auricchio, coordinatore del Programma di Terapia Molecolare al Tigem di Pozzuoli e professore ordinario di Genetica Medica all’Università degli Studi “Federico II” di Napoli. “Molti anni di ricerca in laboratorio ci hanno permesso di sviluppare e testare un vettore di origine virale capace di trasportare una versione corretta del gene difettoso nei pazienti. Somministrato una volta sola attraverso il sangue, il vettore può raggiungere le cellule del fegato e indurle a produrre in maniera stabile, per anni, l’enzima responsabile dello smaltimento del dermatan solfato. Il nostro è stato il primo test nell’uomo di un approccio di terapia genica diretta al fegato per una malattia metabolica da accumulo.”
Come si legge nella pubblicazione, lo studio clinico di Fase I/II puntava a valutare la sicurezza e l’efficacia di AAV2/8.TBG.hARSB, una terapia genica rivolta a giovani pazienti con MPS VI. A tal fine, sono stati arruolati 9 bambini e ragazzi di età compresa tra 5 e 29 anni che, sulla base della dose di vettore ricevuta, sono stati suddivisi in tre gruppi (Low-dose, LD, 6×1011 copie di genoma/kg; Intermediate-dose, ID, 2×10112 copie di genoma/kg; e High-dose, HD, 6×10112 copie di genoma/kg). Il principale obiettivo dello studio era quello di valutare la sicurezza di questa terapia che non ha prodotto effetti collaterali significativi nei nove partecipanti, confermando quanto già osservato negli studi preclinici.
In seconda battuta i ricercatori hanno cercato di comprendere se la terapia fosse in grado di ripristinare una produzione di enzima sufficiente a “detossificare” l’organismo. I pazienti delle coorti di studio con il dosaggio più basso e intermedio (LD e ID) hanno raggiunto una produzione di ARSB pari al 20% dei valori normali e hanno dovuto far ricorso alla terapia enzimatica per un rialzo delle concentrazioni urinarie dei glicosaminoglicani. Quelli nella coorte con il dosaggio più elevato (HD) hanno ottenuto una sostenuta produzione di ARSB - dal 30 al 100% dei valori normali - e solo un modesto rialzo dei glicosaminoglicani urinari.
“I pazienti che hanno ricevuto questo nuovo farmaco non hanno avuto effetti avversi, per cui l’obiettivo principale dello studio è stato raggiunto”, spiega Nicola Brunetti-Pierri, responsabile della Ricerca Traslazionale del Tigem di Pozzuoli e professore ordinario di Genetica Medica all’Università degli Studi “Federico II” di Napoli. “Inoltre, dopo l’infusione siamo riusciti per la prima volta a rilevare l’enzima nel sangue, cosa impossibile prima in questi pazienti: una dimostrazione di come il trasferimento genico abbia effettivamente funzionato. Chi ha ricevuto una dose di farmaco bassa o media ha avuto dei miglioramenti, ma non sufficienti per sospendere completamente la terapia enzimatica. Quelli che invece hanno ricevuto la dose più alta sono tuttora liberi dalla terapia enzimatica: un dato stabile dal punto di vista sia clinico sia di laboratorio. Dobbiamo a tutti un grande ringraziamento, perché hanno mantenuto fede al patto tra pazienti e ricercatori, affidando alla ricerca le loro speranze di una qualità di vita migliore".
I ricercatori continueranno a monitorare nel tempo i pazienti, per valutare gli effetti della correzione genica e il loro stato di salute, ma questi risultati, frutto di anni di impegno e ricerca nel campo delle mucopolisaccaridosi, confermano che la strada imboccata è quella giusta.
È possibile ascoltare il contributo del prof. Alberto Auricchio sulla storia della terapia genica, e gli avanzamenti della ricerca in questo settore, nella seconda puntata del podcast “Reshape – un viaggio nella medicina del futuro” realizzato da Osservatorio Terapie Avanzate e disponibile gratuitamente sulle più note piattaforme di podcast.