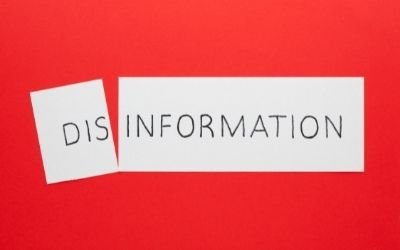Uno studio statunitense fa luce sui profili psicosociali delle persone che cadono vittime della disinformazione sanitaria sul web e sui social media. Ovvero su quali terreni la gramigna attecchisce meglio
Durante la pandemia di COVID-19, diversi progetti di ricerca sono stati avviati con l’obiettivo di comprendere la natura, la prevalenza e la diffusione della disinformazione relativa alla salute. L’emergenza sanitaria, infatti, ha reso più evidente questa problematica che, da anni, affligge il web. Fino ad oggi, però, pochi sono stati gli studi capaci di delineare il profilo dell’utente vittima della disinformazione. Per colmare questa lacuna, un team di ricercata statunitense ha condotto un’indagine originale per comprendere meglio quali siano le caratteristiche delle persone più vulnerabili a credere alle “fake news” in ambito sanitario, e se questa tendenza dipenda dall’argomento trattato. Lo studio è stato pubblicato su American Journal of Public Health.
Ogni agricoltore che si rispetti, infatti, sa che la conoscenza del terreno su cui semina è di importanza fondamentale per la buona riuscita del raccolto. La gramigna è una pianta infestante, cresce bene un po’ ovunque, ma predilige i terreni argillosi e molto umidi. Saperlo è necessario per riuscire a disinfestare il terreno. La disinformazione sanitaria è la nuova ‘gramigna del web’: infestante e dilagante. Influenza le decisioni che le persone prendono riguardo alla loro salute e rischia di diventare una minaccia per il benessere pubblico. Con un ulteriore effetto deleterio di polarizzazione delle opinioni. Negli ultimi anni i social media hanno amplificato questo problema, rendendo più facile l’accesso e la condivisione di informazioni sanitarie viziate o scorrette, con pochi e semplici clic.
Per affrontare il problema della disinformazione sanitaria è necessario identificare il tipo di persona che è maggiormente vulnerabile alla ‘gramigna del web’. Per farlo i ricercatori hanno individuato sui social network 24 post emblematici, di cui 12 erano veri (o per lo più veri), i restanti 12 falsi (o prevalentemente falsi). I post sono stati raccolti dalle piattaforme Twitter e Facebook e trattavano tre argomenti: l’utilizzo delle statine per il colesterolo, la cura del cancro e il vaccino contro il papilloma virus (HPV). I ricercatori hanno quindi somministrato un questionario online a 923 adulti statunitensi, chiedendo loro di valutare l'accuratezza di ciascuno di questi 24 post. Agli intervistati, inoltre, è stato chiesto di rispondere ad alcune domande costruite ad hoc per sondare la probabilità che il loro comportamento potesse essere influenzato da queste affermazioni. Ad esempio: “Se ti venisse prescritta una statina, questo post potrebbe influenzare la tua decisione di assumerla?”
In contemporanea, i partecipanti allo studio sono stati invitati a completare un questionario di valutazione, che ha permesso ai ricercatori di accertare il loro livello di istruzione e di alfabetizzazione sanitaria, l'atteggiamento verso la medicina alternativa, il ragionamento scientifico, la capacità di pensiero riflessivo, la generale fiducia nella scienza e nell'assistenza sanitaria. Hanno anche indicato se avevano una diagnosi di cancro, HPV o colesterolo alto e se stavano assumendo statine.
L'analisi dei risultati ha rivelato che le valutazioni di accuratezza per i post ingannevoli erano tutte correlate positivamente, indipendentemente dall’argomento trattato. Questo significa che un individuo propenso a reputare valida un’informazione scorretta sul tema della terapia per il cancro è maggiormente a rischio di credere ad altre affermazioni altrettanto false sul colesterolo alto o sul papilloma virus. Alcuni individui, quindi, sono generalmente più suscettibili alla disinformazione, a prescindere dall’argomento sanitario. Sono terreni più favorevoli alla crescita delle piante infestanti.
Per capire quali caratteristiche rendono queste persone più vulnerabili, i ricercatori hanno preso in esame diversi profili psicosociali. Tra tutti, quattro si sono distinti come più affidabili tra i predittori di suscettibilità alla disinformazione: minore alfabetizzazione sanitaria, livello di istruzione inferiore, fiducia nella medicina alternativa e scarsa fiducia nel sistema sanitario. A supporto di questa ipotesi, i ricercatori hanno evidenziato che, da sole, queste quattro caratteristiche rappresentavano il 19% della varianza, mentre gli effetti cumulativi di tutte le altre ne costituivano solo l'8%. Tra queste ultime i ricercatori annoverano: la fiducia nella scienza, l’approccio olistico alla salute, la presenza di un problema medico correlato agli argomenti in questione (colesterolo alto, cancro, ecc.). Quindi, anche la rilevanza personale non è indicativa di una maggiore propensione a credere a informazioni false sul tema.
Nonostante i considerevoli risultati ottenuti con questo studio, la strada da percorrere per debellare la ‘gramigna del web’ è ancora lunga. Gli stessi autori si augurano che altre ricerche proseguano su questa scia, magari ampliando geograficamente il campione al di fuori dei confini degli Stati Uniti o includendo altri argomenti di salute oltre a quelli già presi in considerazione.
L’ondata di fake news scientifiche che in questi ultimi anni sta invadendo il web e l’infodemia che che stiamo affrontando con la pandemia ha evidenziato questo problema, rendendo i terreni umidi e argillosi. È proprio in questo contesto che emerge il ruolo fondamentale delle fonti attendibili, delle testate giornalistiche specialistiche affidabili e puntuali (di cui Osservatorio Terapie Avanzate fa ormai parte da oltre due anni). La divulgazione scientifica in ambito biomedico da semplice veicolo di informazioni corrette può diventare vera e propria promozione della salute.