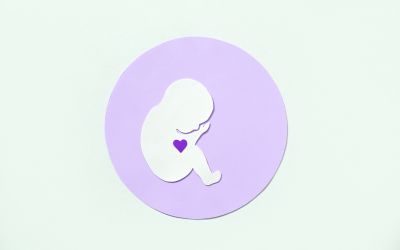Sono i primi organoidi realizzati con cellule prelevate da gravidanze in corso e aprono nuove prospettive per la diagnosi e terapia personalizzata delle malattie del feto
Nel libro “Il mio paziente non è ancora nato”, Giancarlo di Renzo, ginecologo e ostetrico, racconta la nascita della medicina fetale e come questa sia stata uno “shock culturale”. Se prima il feto era considerato solo un’appendice della madre, oggi qualunque medico sa che durante la gravidanza i pazienti sono almeno due. Ora in una piastra da laboratorio si può addirittura riprodurre una miniatura degli organi fetali a partire dalle cellule staminali prelevate dal liquido amniotico, senza rischi per il feto o per la madre. È ciò che ha fatto un team di ricerca italo-britannico - guidato dal prof. Paolo De Coppi, del Great Ormond Street Institute of Child Health (GOS ICH) all’University College di Londra - il cui studio è stato pubblicato su Nature Medicine. Si tratta del primo organoide fetale di una gravidanza ancora in corso e apre nuovi scenari per la diagnosi e terapia personalizzata delle malattie del feto.
Per creare gli organoidi, i ricercatori possono partire da cellule staminali embrionali, in grado di dare origine a qualsiasi tipo cellulare, o da biopsie di tessuti adulti – in questo secondo caso, però, le cellule mature vengono riportate indietro nel tempo allo stadio di cellule staminali pluripotenti e nuovamente riprogrammate per differenziarsi nel tipo cellulare desiderato. I risultati sono stati rivoluzionari soprattutto per alcuni tessuti come cervello, retina e cuore. Lo stesso Coppi, ad esempio, nel 2021 ha guidato uno studio per realizzare dei mini-stomaci per studiare gli effetti dell’infezione da Sars-Cov-2 sul sistema gastrointestinale (ne abbiamo parlato qui).
Esistono anche gli organoidi fetali, che permettono di studiare lo sviluppo del feto e l’insorgenza di difetti congeniti, che riguardano circa il 5-6% dei nati. Queste condizioni, pur essendo individualmente rare o molto rare, se considerate nel loro insieme interessano 8 milioni di bambini ogni anno in tutto il mondo, oltre 20.000-25.000 in Italia. Il problema di realizzare organoidi a partire da cellule fetali è che queste sono difficilmente reperibili, anche per questioni etiche o legali. La fonte principale è rappresentata dagli aborti spontanei, ma la maggior parte avviene prima della 16esima settimana, mentre molti difetti congeniti insorgono più tardi o richiedono più tempo per monitorare la loro progressione.
Ma esiste un’alternativa. I ricercatori sanno da decenni che il liquido amniotico, che circonda e protegge il feto nell’utero, contiene cellule fetali. È il principio che guida, ad esempio, la pratica dell’amniocentesi, per accertare la presenza di eventuali anomalie congenite come la sindrome di Down o malattie genetiche come l’anemia falciforme o la fibrosi cistica. Ma la stragrande maggioranza di queste cellule, il 95% o più, sono cellule morte eliminate dal feto. Una frazione molto più piccola e dalla composizione ancora incerta è rappresentata, invece, da cellule vive. Una parte è costituita da cellule progenitrici, un tipo di cellule staminali dette anche “multipotenti”, perché, al contrario delle pluripotenti, possono differenziare solo in un tipo cellulare specifico. Quelle presenti nel liquido amniotico sono del tipo epiteliale, possono cioè dare origine solo allo strato più esterno che riveste la superficie degli organi. Sono cellule che hanno una naturale tendenza a unirsi in strutture multicellulari: come gli organoidi, repliche 3D degli organi o tessuti umani.
Il team di ricerca italo-britannico ha usato le cellule progenitrici del liquido amniotico, ottenute da 12 gravidanze tra la 16esima e la 34esima settimana. Le cellule sono state prelevate in occasione di esami programmati per le operazioni di screening e di diagnosi prenatali, senza nessun danno per il feto o la madre. Questo sistema ha molti vantaggi, ad esempio permette di realizzare organoidi da gravidanze ancora in corso. In 4-6 settimane, i ricercatori possono generare l’organoide e testare farmaci o terapie personalizzate per curare le malattie del feto. Per fare un paragone, con le cellule staminali embrionali i tempi sono molto più lunghi, dai 5 ai 9 mesi.
Le cellule progenitrici, inoltre, sono naturalmente programmate per differenziarsi in un tipo cellulare specifico: in un gel di coltura adatto, nel giro di poche settimane esprimono spontaneamente il loro potenziale, senza bisogno di ulteriori manipolazioni o riprogrammazioni. I ricercatori hanno isolato dal liquido amniotico tre tipi di cellule progenitrici, rene, polmone e intestino: tutti e tre hanno formato spontaneamente gli organoidi replicando le caratteristiche morfologiche e funzionali del tessuto di origine ed esprimendo i geni e le proteine corretti.
Una delle applicazioni esplorate nello studio è stata quella di ricreare un modello di malattia fetale. Molti difetti congeniti possono essere scoperti e monitorati con tecniche di imaging sempre più sofisticate, ma gli organoidi possono fornire informazioni extra sulla severità della patologia e sulla funzionalità degli organi colpiti. In questo caso, i ricercatori hanno ricreato un modello di ernia diaframmatica congenita (CDH), un difetto embrionale caratterizzato dal mancato sviluppo o dallo sviluppo incompleto del diaframma. Questo comporta che gli organi addominali premano contro la cavità toracica, comprimendo i polmoni e spostando il cuore. Solo il 70% dei feti sopravvive a questa condizione, perché la compressione impedisce ai polmoni di svilupparsi correttamente.
I ricercatori hanno creato gli organoidi di polmone a partire da cellule di feti con CDH e li hanno messi a confronto con gli organoidi “sani”. All’inizio i due sembrano identici, ma durante lo sviluppo emergono le differenze: quelli CDH producono meno surfattante, una sostanza fondamentale per la respirazione, e presentano una crescita e differenziazione cellulare irregolare. Questa condizione è curabile inserendo nella trachea del feto un palloncino che respinge gli organi addominali al loro posto, decomprimendo i polmoni. Prelevando le cellule dal liquido amniotico prima e dopo la procedura con il palloncino, i ricercatori hanno osservato un miglioramento nelle condizioni degli organoidi, che riprendono a svilupparsi in maniera paragonabile a quelli sani.
Lo scopo finale è quello di “accedere al feto senza toccare il feto”. Il modello di CDH, ad esempio, può aiutare a capire quale è lo stato reale dei polmoni, se la terapia chirurgica è veramente necessaria e persino se ha funzionato o meno. La tecnologia però permette di creare organoidi solo a partire dalle cellule epiteliali rilasciate nel liquido amniotico, rimangono fuori alcuni organi fondamentali come il cuore o il cervello e i difetti congeniti che colpiscono altri tipi cellulari, come quelle mesenchimali. La ricerca ha quindi tracciato la via ma il percorso è ancora lungo e merita un’approfondita esplorazione.