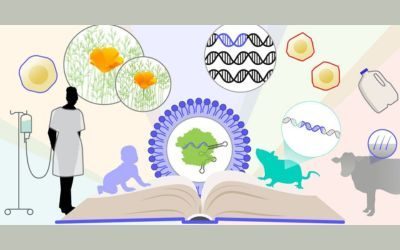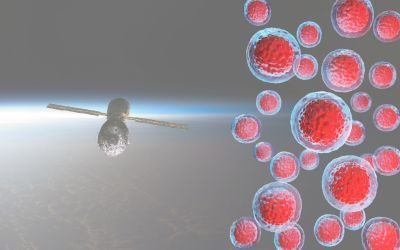News
Base editing per affinare il riconoscimento cellulare nelle leucemie
Uno studio svizzero punta alla combinazione di strategie di immunoterapia e di base editing per colpire le cellule tumorali senza danneggiare quelle sane
Se trenta anni fa aveste chiesto agli scienziati di scommettere sui più promettenti campi di studio da cui ottenere soluzioni valide nella lotta al cancro, molti avrebbero puntato sulla possibilità di bloccare la replicazione cellulare, altri sui sistemi che impediscono alle cellule di entrare in apoptosi. Quasi nessuno avrebbe creduto nelle possibilità del sistema immunitario di combattere le cellule cancerose. Oggi, invece, l’immunoterapia è una collaudata pratica clinica alla cui radice c’è la comprensione della sofisticata capacità di riconoscimento delle cellule tumorali. Ed è grazie ai più innovativi strumenti di editing del genoma che ricercatrici come Romina Marone e Jessica Zuin, del Dipartimento di Biomedicina dell’Università e dell’Ospedale di Basilea (Svizzera), stanno lavorando per mettere a punto nuovi approcci per rendere ancora più mirato il riconoscimento cellulare con l’obiettivo di permettere di rinnovare il sistema ematopoietico di una persona malata di leucemia, distruggendo le cellule malate ma risparmiando quelle sane. La strategia è stata descritta in un articolo pubblicato sulla rivista Nature.
- Di: Enrico Orzes
La bioetica dell’editing genetico in dodici domande e risposte
L’Innovative Genomics Institute di Jennifer Doudna ha pubblicato un nuovo capitolo dell’enciclopedia libera di CRISPR dedicato alle problematiche morali della correzione del DNA
La premessa è doverosa: i giudizi etici sono influenzati da cultura di appartenenza, religione, esperienze di vita, valori personali e altro ancora. Non può esistere, dunque, un solo modo di tracciare il confine tra giusto e sbagliato, né di soppesare i pro e i contro di una tecnica versatile come l’editing genomico. Di conseguenza il nuovo contributo pubblicato online nella sezione CRISPRpedia, curato dalla bioeticista di Berkeley Jodi Halpern insieme alla divulgatrice Hope Henderson, non vuole essere un decalogo di imperativi morali. Rappresenta piuttosto una rassegna ragionata dei punti critici più dibattuti e costituisce una bussola utile per insegnanti e studenti, medici e pazienti, e in generale per tutte le persone curiose.
- Di: Anna Meldolesi
Rigenerazione corneale: uno studio pionieristico dal Giappone
Pubblicati i primi risultati sul trapianto di cellule staminali pluripotenti indotte effettuato su 4 pazienti affetti da diverse forme di deficit di cellule staminali limbari, rara condizione che colpisce la vista
La perdita delle cellule staminali limbari, che sono localizzate al margine della cornea, ha gravi conseguenze per la vista: perdita di chiarezza corneale, cicatrici corneali, infiammazione cronica e potenziale perdita della vista. Il deficit di cellule staminali limbari (LSCD) è una condizione rara caratterizzata dalla perdita o dalla carenza di cellule staminali nel limbus, vitali per il ripopolamento dell'epitelio corneale: quando queste cellule staminali vengono perse, l'epitelio corneale non è in grado di ripararsi e rinnovarsi. Uno studio pubblicato a novembre su The Lancet ha documentato i primi interventi di trapianto corneale realizzati utilizzando lembi di tessuto prodotti a partire da cellule staminali pluripotenti indotte (iPSC), aprendo così nuove prospettive per il trattamento di questa condizione.
- Di: Rachele Mazzaracca
Cellule staminali “spaziali”: la frontiera della medicina rigenerativa
Lo spazio potrebbe rendere le staminali più performanti per l’uso terapeutico. La microgravità permette alle cellule di proliferare più rapidamente e mantenere la loro “staminalità” più a lungo
Chi ha meno di 25 anni non ha mai vissuto un singolo giorno senza che ci fossero persone nello spazio. Dal 2 novembre 2000 la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è stata sempre abitata da un equipaggio variabile tra i 2 e i 7 astronauti. Un vero laboratorio di ricerca sopra le nostre teste, in orbita costante intorno alla Terra, in cui gli scienziati possono condurre esperimenti in condizioni uniche di microgravità. A bordo della ISS, i ricercatori della Mayo Clinic, una organizzazione no-profit statunitense, hanno studiato il comportamento delle cellule staminali, confrontandole con le loro “gemelle” rimaste sulla Terra. Le cellule coltivate nello spazio crescono più velocemente e hanno qualità uniche, che potrebbero accelerare la scoperta di nuove terapie per curare malattie complesse. L’articolo pubblicato su NPJ Microgravity fa il punto sugli esperimenti condotti fino ad ora.
- Di: Erika Salvatori
Agenda
News da CRISPeR MANIA
a cura di Anna Meldolesi