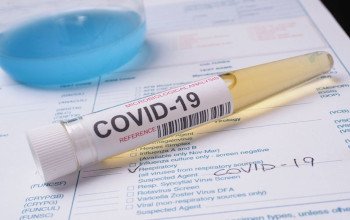La Food and Drug Administration (FDA) ha concesso la prima autorizzazione d’emergenza e la ricerca scommette su innovazioni ancora più ambiziose per la diagnosi delle malattie emergenti.
La pandemia ha dimostrato che i classici tamponi basati sulla reazione a catena della polimerasi (PCR) non bastano più. Rappresentano il golden standard della diagnostica ma richiedono reagenti difficili da reperire durante un’emergenza globale come questa, macchinari costosi, competenze specialistiche e troppo tempo per l’esecuzione. Il futuro del settore diagnostico è nei test rapidi, possibilmente da fare anche a casa e auspicabilmente in multiplex. A che punto è la transizione? La velocità è un requisito ormai a portata di mano, al traguardo dell’home-testing si sta lavorando e la fattibilità di chip capaci di eseguire simultaneamente centinaia di test diversi è già stata dimostrata in laboratorio.
L’ultima notizia è del 6 maggio, questa data verrà segnata nel calendario di CRISPR come il debutto ufficiale di questa tecnologia in campo diagnostico. L’ente regolatorio statunitense (FDA), infatti, ha dato il via libera al primo test basato su CRISPR, utilizzando la procedura accelerata prevista per le emergenze sanitarie. La piattaforma CRISPR in questo caso non serve per l’editing delle sequenze genetiche, ma per il loro rilevamento. Il prelievo del campione da analizzare può essere fatto catturando per sfregamento le cellule della mucosa nasale oppure faringea, come con i tamponi classici, ma sembra funzionare bene anche la saliva. Poi, nello stesso passaggio, avvengono l’amplificazione e il riconoscimento dell’acido nucleico virale. Il trucco è stato trovare un enzima del sistema CRISPR capace di riconoscere e tagliare le sequenze bersaglio alla stessa temperatura richiesta dai reagenti per l’amplificazione. La soluzione è arrivata dal batterio che dà un cattivo sapore al succo d’arancia andato a male, Alicyclobacillus acidophilus, che contiene un enzima della famiglia Cas detto AapCas12b. Grazie a questa proteina, e a un marcatore fluorescente, è possibile rilevare il nuovo coronavirus anche se nel campione ce ne sono solo un centinaio di copie. Confrontandolo con i test validati clinicamente, il nuovo test ha dimostrato di avere una sensibilità del 97% e una specificità del 100%.
Questo test, appena autorizzato dal FDA, si chiama STOPCovid (Sherlock Testing in One Pot) perché è un’evoluzione della piattaforma Sherlock, annunciata su Science nel 2017 dal gruppo di Feng Zhang del Broad Institute e già utilizzata negli ospedali della Tailandia per identificare Sars-Cov2. Alcuni gruppi in Italia ne hanno già fatto richiesta per poterlo mettere alla prova (il modulo da riempire è sul sito stopcovid.science). Il protocollo richiede un addestramento minimo e un equipaggiamento alla portata di qualsiasi laboratorio, come provette e bagni termostatici.
Il prossimo traguardo sarà una versione Poc, ovvero “point-of-care”, che possa essere usata in modo decentralizzato, a casa, in farmacia o sui luoghi di lavoro, senza richiedere passaggi in laboratorio. L’azienda produttrice, la Sherlock Biosciences, ci sta già lavorando ma quando questo test sarà pronto dovrà essere autorizzato separatamente dalla Food and Drug Administration. Il fronte più avanzato della ricerca, invece, consiste in un processo di miniaturizzazione incentrato sull’uso di chip microfluidici. Si tratta di tanti micro-pozzetti per reagenti, organizzati su un supporto di gomma grande quanto un telefonino. Un singolo chip può identificare un determinato ceppo virale in oltre mille campioni, oppure 169 virus (tanti sono i virus di cui conosciamo bene il genoma) in una manciata di campioni. La tecnologia che consente di farlo si chiama CARMEN (Combinatorial Arrayed Reactions for Multiplexed Evaluation of Nucleic acids) e potrebbe consentire ai medici di scoprire in meno di 8 ore se un paziente è affetto da più infezioni contemporaneamente oppure testare una popolazione per una singola malattia. Il prototipo CARMEN è basato sul test Sherlock ed è stato presentato dal Broad Institute il 29 aprile su Nature.