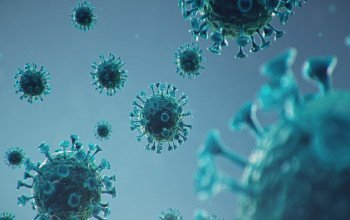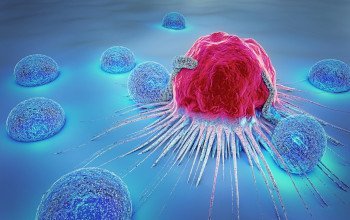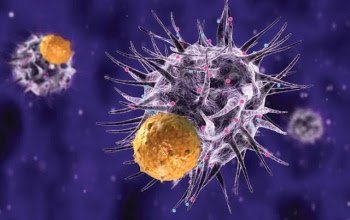CAR-T e Immunoterapia
CAR-T e immunoterapia: la nuova frontiera delle terapie oncologiche
L’immunoterapia è oggi considerata l’ultima frontiera della lotta al cancro e si basa sul concetto rivoluzionario di combattere i tumori come se fossero un’infezione, ovvero “armando” il sistema immunitario del paziente in maniera tale da riconoscere le cellule tumorali e annientarle.
Le cellule tumorali sono cellule che hanno una proliferazione incontrollata e vengono normalmente riconosciute come estranee e dannose dal sistema immunitario, il quale scatena un attacco da parte dei linfociti T, considerati i “soldati di assalto”. Questa difesa dell’organismo non è però sempre efficace perché le cellule tumorali riescono ad attuare tutta una serie di strategie di fuga. Una di queste trae vantaggio dal meccanismo di autoregolazione del sistema immunitario basato su una serie di proteine che agiscono come “acceleratori” o “freni” sulle cellule T.
Una delle strategie di immunoterapia utilizzate oggi, chiamata “inibizione dei checkpoint immunologici”, si basa sull’impiego di anticorpi per disinnescare i freni del sistema immunitario e aumentare così la capacità dei linfociti di fronteggiare i tumori. L’idea, nata negli anni ’90 e arrivata alla prima applicazione terapeutica nel 2011, si è meritata l’assegnazione del Premio Nobel per la Medicina nel 2018.
CAR-T: LINFOCITI T POTENZIATI CONTRO LE CELLULE TUMORALI
Un’altra strategia, di ultimissima generazione e denominata CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T cell therapies), si basa invece sull’ingegnerizzazione genetica dei linfociti T in maniera tale da potenziarli per combattere i tumori. Nello specifico, le cellule T vengono prelevate dal sangue del paziente, modificate geneticamente in modo tale da esprimere sulla loro superficie il recettore CAR capace di aumentare la risposta immunitaria, e reinfuse nel paziente stesso. A differenza della strategia basata sugli inibitori dei checkpoint, le CAR-T rappresentano la medicina personalizzata nel campo dei tumori. Ogni dose viene sviluppata e prodotta per un singolo paziente partendo dalle sue stesse cellule immunitarie. Le prime approvazione per l’applicazione delle CAR-T nei pazienti con alcuni tumori del sangue (leucemia linfoblastica nel bambino e linfoma nell’adulto) sono arrivate nel 2017 negli Stati Uniti e nel 2018 in Europa.
I pazienti continuano a ricevere le cure salvavita programmate. Alcuni rallentamenti riguardano invece gli studi clinici per altre terapie avanzate. Ne abbiamo parlato con Franco Locatelli.
Le terapie avanzate sembrano resistere all’impatto che lo tsunami COVID-19 sta provocando in tutto il mondo. Almeno per il momento. Il blocco dei voli tra i diversi Paesi, infatti, ha messo a serio rischio il trasporto di materiale cellulare necessario sia per i trapianti di cellule staminali, che spesso provengono da donatori residenti in Paesi esteri, sia per le terapie cellulari CAR-T, che nella stragrande maggioranza dei casi vengono ingegnerizzate negli Stati Uniti. Per ora però le soluzioni intraprese sembrano garantire le cure salvavita, come conferma anche Franco Locatelli - Direttore del Dipartimento di Onco-Ematologia e Terapia Cellulare e Genica, IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e Presidente del Consiglio Superiore di Sanità. Mentre a risentirne un po’ di più sono i trial clinici.
- Di: Cristina Tognaccini
Ricorrendo a tecniche di editing del genoma un gruppo di ricerca finlandese ha studiato quali molecole possono aumentare l’effetto terapeutico delle CAR-T limitandone gli effetti collaterali.
La storia dell’oncologia insegna che la ricerca di “un’unica cura contro tutti i tipi di tumore” è un po’ come la ricerca della pietra filosofale. È uno slogan che medici e ricercatori di tutto il mondo sanno bene non avere attinenza con la realtà che punta, invece, a combinazioni di farmaci e strategie terapeutiche per giungere alla tanto agognata vittoria. Così anche adesso, con l’approvazione delle terapie CAR-T, non basta pensare di produrre e somministrare ai pazienti le cellule ingegnerizzate contando unicamente su un loro successo garantito, ma serve predisporre la strada a questi “superlinfociti”, facilitandone l’azione e anche limitandone i possibili effetti avversi.
- Di: Enrico Orzes
La clorotossina è stata usata per sviluppare una terapia più precisa ed efficace per questo grave tumore del cervello. In avvio uno studio clinico negli Stati Uniti.
Certe volte anche le cose negative possono tornare utili, o come si suol dire “non tutto il mal vien per nuocere”. Cosi è per il caso del veleno dello scorpione: utilizzato da un gruppo di scienziati, dell’Istituto per i Tumori “City of Hope” in California, per sviluppare una nuova versione di terapia CAR-T per il glioblastoma. La clorotossina (CLTX) estratta dal veleno dello scorpione, infatti, già in precedenza aveva dimostrato la capacità di riconoscere e legarsi alle cellule di questo grave tumore cerebrale. Motivo per cui il team di ricerca ha deciso di utilizzarla per progettare un nuovo recettore dell'antigene chimerico (CAR) in grado di superare le limitazioni delle attuali terapie CAR-T per il glioblastoma, che finora sono risultate non efficaci. Lo studio preclinico è stato pubblicato il 4 marzo su Science Translational Medicine e sulla base di questi risultati è in partenza un trial clinico di Fase I.
- Di: Cristina Tognaccini
Secondo un recente studio, oltre alle cause di resistenza già note, un’altra potrebbero essere attribuita alle cellule tumorali “immortali”
È caccia aperta al colpevole che provoca una resistenza alle terapie CAR-T finora approvate (Kymriah sviluppata da Novartis e Yescarta da Gilead) nel 10-20% dei pazienti con leucemia linfoblastica acuta (LLA). Sebbene infatti, si tratti di terapie rivoluzionarie che hanno drasticamente cambiato il modo di trattare alcuni tumori del sangue, come la LLA, molto resta ancora da fare sia per ridurne la potenziale tossicità sia per capire cosa induce la resistenza al trattamento. Un recente studio ha ipotizzato che il motivo della mancata efficacia in alcuni pazienti potrebbe risiedere nelle cellule tumorali stesse.
- Di: Cristina Tognaccini
Una ricerca preclinica ha mostrato che utilizzare le nanoparticelle per veicolare l’RNA messaggero attraverso la membrana delle cellule T potrebbe portare a minori effetti collaterali
Punti di forza e punti critici sono intrinsechi di ogni fatto, persona o cosa. Le terapie CAR-T non escluse. Da quando sono arrivate sul mercato statunitense nel 2017 infatti, la comunità scientifica oltre a decantarne i vantaggi, ha continuato a lavorarci per migliorarle ulteriormente ed estenderne ancora le potenzialità. Un punto particolarmente importante su cui diversi gruppi di ricerca sono impegnati è la sicurezza, che può ancora essere migliorata. Proprio su questo fronte alcuni scienziati dell’Università della Pennsylvania hanno sviluppato di recente un sistema sperimentale per produrre cellule CAR-T meno tossiche, sfruttando per la manipolazione genetiche nanoparticelle che veicolano l'RNA messaggero (mRNA), anziché il classico virus contenente il DNA.
- Di: Cristina Tognaccini
L’Ospedale Bambino Gesù mette a punto un protocollo per bloccare gli effetti collaterali della terapia, mentre l’Humanitas crea un team multidisciplinare per la valutazione dei pazienti da inserire nei programmi di trattamento.
Da mesi non si fa che parlare d’altro: le terapie CAR-T costituiscono al di fuori di ogni dubbio uno dei traguardi medici più importanti del nuovo secolo. Nella battaglia contro i tumori. Ai loro successi - e anche ai loro limiti - sono stati dedicati centinaia di lavori tra articoli, saggi e pamphlet ma finalmente le terapie che trovano in Kymriah (Novartis) e Yescarta (Gilead) i due più celebri protagonisti di questa pagina della medicina entrano nelle stanze degli ospedali. E lo fanno con due fatti esemplificativi: l’attivazione di un’unità speciale presso il centro Humanitas di Rozzano per la gestione dell’intero percorso clinico dei pazienti e la sperimentazione presso l’Ospedale Bambino Gesù di un protocollo per ridurre gli effetti collaterali della terapia.
- Di: Enrico Orzes
Agenda
News da CRISPeR MANIA
a cura di Anna Meldolesi