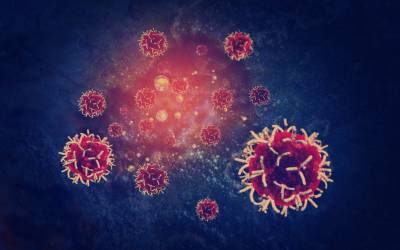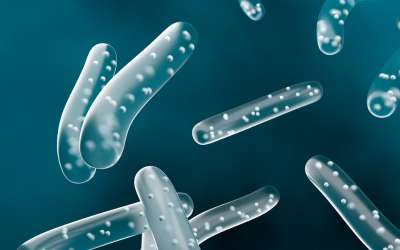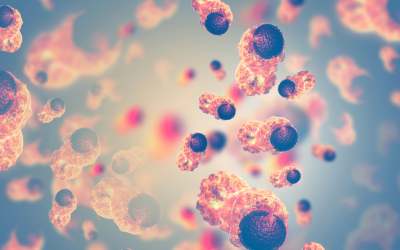CAR-T e Immunoterapia
CAR-T e immunoterapia: la nuova frontiera delle terapie oncologiche
L’immunoterapia è oggi considerata l’ultima frontiera della lotta al cancro e si basa sul concetto rivoluzionario di combattere i tumori come se fossero un’infezione, ovvero “armando” il sistema immunitario del paziente in maniera tale da riconoscere le cellule tumorali e annientarle.
Le cellule tumorali sono cellule che hanno una proliferazione incontrollata e vengono normalmente riconosciute come estranee e dannose dal sistema immunitario, il quale scatena un attacco da parte dei linfociti T, considerati i “soldati di assalto”. Questa difesa dell’organismo non è però sempre efficace perché le cellule tumorali riescono ad attuare tutta una serie di strategie di fuga. Una di queste trae vantaggio dal meccanismo di autoregolazione del sistema immunitario basato su una serie di proteine che agiscono come “acceleratori” o “freni” sulle cellule T.
Una delle strategie di immunoterapia utilizzate oggi, chiamata “inibizione dei checkpoint immunologici”, si basa sull’impiego di anticorpi per disinnescare i freni del sistema immunitario e aumentare così la capacità dei linfociti di fronteggiare i tumori. L’idea, nata negli anni ’90 e arrivata alla prima applicazione terapeutica nel 2011, si è meritata l’assegnazione del Premio Nobel per la Medicina nel 2018.
CAR-T: LINFOCITI T POTENZIATI CONTRO LE CELLULE TUMORALI
Un’altra strategia, di ultimissima generazione e denominata CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T cell therapies), si basa invece sull’ingegnerizzazione genetica dei linfociti T in maniera tale da potenziarli per combattere i tumori. Nello specifico, le cellule T vengono prelevate dal sangue del paziente, modificate geneticamente in modo tale da esprimere sulla loro superficie il recettore CAR capace di aumentare la risposta immunitaria, e reinfuse nel paziente stesso. A differenza della strategia basata sugli inibitori dei checkpoint, le CAR-T rappresentano la medicina personalizzata nel campo dei tumori. Ogni dose viene sviluppata e prodotta per un singolo paziente partendo dalle sue stesse cellule immunitarie. Le prime approvazione per l’applicazione delle CAR-T nei pazienti con alcuni tumori del sangue (leucemia linfoblastica nel bambino e linfoma nell’adulto) sono arrivate nel 2017 negli Stati Uniti e nel 2018 in Europa.
La FDA sta approfondendo alcuni casi sospetti, ma al momento non ci sono conferme e secondo tutti gli esperti i benefici dei trattamenti superano di gran lunga i rischi legati agli eventi avversi
Un trattamento in grado di armare il sistema immunitario e metterlo nelle condizioni di prevalere su tumori del sangue, come la leucemia e il linfoma, sfuggiti al controllo terapeutico. Ecco cosa sono le terapie a base di cellule CAR-T: una potente rivoluzione per la medicina. Ma, come ogni rivoluzione che si rispetti, anche le CAR-T sono accompagnate da qualche rischio. Così, mentre la comunità dei pazienti chiede a gran voce accesso a queste terapie salvavita e quella dei ricercatori lavora per elaborare versioni sempre più efficaci di linfociti T ingegnerizzati, gli organismi regolatori ne indagano la sicurezza e i rischi. Esattamente come sta facendo la Food and Drug Administration (FDA) statunitense per capire se le CAR-T siano o meno correlate a un certa probabilità di sviluppare secondi tumori.
- Di: Enrico Orzes
I risultati di uno studio pubblicato su Nature indicano nella riattivazione di un virus la causa di effetti avversi neurotossici legati al trattamento con CAR-T
Lo scorso anno sulla rivista The New England Journal of Medicine è stato pubblicato il caso di una paziente di 49 anni, trattata con terapie a base di cellule CAR-T in seguito alla comparsa di un linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) e poi colpita da una severa forma di disorientamento. Nessun trauma, né crisi epilettica, nessuna traccia di nausea o problematiche annesse di alcun genere, ma la donna appariva confusa e incapace di parlare correttamente, scrivere o contare. Il sospetto di un’encefalopatia aveva indotto i medici a sottoporla ad accertamenti ma un’ipotesi plausibile per l’origine dei suoi problemi è contenuta in un altro articolo, pubblicato recentemente su Nature, in cui si parla della riattivazione del virus HHV-6.
- Di: Enrico Orzes
Un gruppo di ricerca della Columbia University di New York ha elaborato una strategia su modelli animali per superare le barriere del microambiente nei tumori solidi
I cultori della fantascienza ricorderanno come nel film “La guerra dei mondi”, tratta dall’omonimo romanzo di H.G. Weels (1897), siano bastati gli organismi di microscopiche dimensioni, che da sempre abitano il nostro pianeta, per penetrare le difese degli enormi tripodi alieni intenti a distruggere la Terra. Si potrebbe pensare che i ricercatori statunitensi, guidati da Rosa Vincent, si siano ispirati a questo filone fantascientifico quando hanno cominciato gli esperimenti su una nuova piattaforma a base di CAR-T che li ha portati a un’interessatissima pubblicazione comparsa il mese scorso sulla rivista Science. Oggetto dei loro studi, infatti, è l’ingegnerizzazione di ceppi batterici allo scopo di infiltrare il microambiente tumorale e guidare le CAR-T verso i bersagli per cui sono state designate.
- Di: Enrico Orzes
Un approccio di immunoterapia in due fasi per combattere tumori contro cui le attuali versioni delle terapie a base di cellule CAR-T sono inefficaci
“La mossa Kansas City è quando tu guardi a destra e loro arrivano a sinistra”. Con queste parole Bruce Willis metteva in guardia Josh Hartnett nel film “Slevin - patto criminale”, usando uno slang un po’ alla moda per descrivere una truffa in cui la vittima, pur credendo di aver capito l’inganno, viene beffata. Alcuni gruppi di ricerca stanno cercando di adattare questa strategia alle terapie CAR-T: l’obiettivo è renderle adatte a colpire le cellule della leucemia mieloide acuta e di altri tumori che, fino ad oggi, erano rimasti fuori dal radar dei “super-linfociti”. Un recente articolo apparso sulla rivista Science riassume il punto di vista entusiastico - ma pur sempre cauto - di alcuni scienziati riguardo a questa nuova strategia di uso delle CAR-T.
- Di: Enrico Orzes
La strategia che mira al TAG72, bersaglio presente su più tumori solidi, è stata testata con successo nei test preclinici e ora si avvia agli studi clinici
È la frontiera a cui tutti – clinici e ricercatori – ambiscono: sviluppare una terapia a base di cellule CAR-T che sia in grado di colpire ed eliminare i tumori solidi. Ad oggi, infatti, sono state approvate solo CAR-T per i tumori del sangue e da anni si sta cercando di andare oltre, non senza difficoltà. Ogni tanto però qualche passo avanti viene fatto. Uno degli ultimi è stato compiuto dai ricercatori del City of Hope Medical Center in California (Stati Uniti) che hanno testato con successo – in uno studio preclinico – l’efficacia di una terapia con cellule CAR-T contro il cancro ovarico. La ricerca è stata pubblicata lo scorso agosto su Nature Communications.
- Di: Redazione
La ricerca, condotta al Boston Children’s Hospital/Dana Farber Cancer Institute, descrive un metodo per colpire gli antigeni espressi dal tumore e dalle cellule sane senza rischi per i pazienti
Scambiando le vocali del termine “parto” se ne ottiene uno (“porta”) di senso completamente differente. Lo stesso accade invertendo le sillabe: le “vocali” possono così trasformarsi in dei salutari ortaggi (“cavoli”). Nelle lingue, come in biologia, una differenza di un paio di lettere può stravolgere il significato di una parola. In questa plasticità è custodito il segreto per potenziare terapie avanzate come le CAR-T e sconfiggere malattie aggressive fra cui la leucemia mieloide acuta (AML). A spiegare come si possa raggiungere un tale straordinario risultato è Gabriele Casirati, ricercatore italiano al Boston Children’s Hospital/Dana Farber Cancer Institute e autore di una interessante pubblicazione sulla celebre rivista Nature.
- Di: Enrico Orzes
Agenda
News da CRISPeR MANIA
a cura di Anna Meldolesi