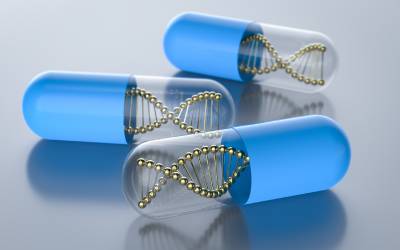Una tecnologia innovativa permette di consultare facilmente i dati memorizzati all’interno delle molecole di DNA, uno tra i più moderni sistemi di archiviazione dati
Nel 2016, i ricercatori hanno memorizzato un breve filmato che ritraeva un cavallo al galoppo nel DNA di un batterio, trasformando l’antico custode dell’informazione genetica in un moderno “hard disk” per il salvataggio dei dati. Come nastri magnetici o dispositivi elettronici, ma con il vantaggio che può rimanere intatto per migliaia di anni e immagazzinare miliardi di miliardi di byte in pochissimo spazio che, con un volume di dati generati ogni giorno nel mondo pari più o meno al download di mezzo miliardo di film in HD, è un ottimo punto a favore. I ricercatori della University of Technology di Eindhoven hanno pubblicato su Nature Nanotechnology un sistema che rende più facile la ricerca e lettura dei dati memorizzati nel DNA, ancora troppo lenta e costosa rispetto agli archivi tradizionali.
Pensare che il DNA un domani possa sostituire nastri magnetici e dispositivi elettronici, sembra quasi fantascienza. Ma tecnicamente è possibile, perché da più di dieci anni ormai siamo in grado di produrre le stringhe di DNA per via sintetica, in maniera sempre più veloce e a costi sempre più bassi.
La natura stessa del DNA lo rende un candidato ideale per archiviare informazioni. Con la sua sequenza di “lettere” - i nucleotidi - è già a tutti gli effetti una memoria naturale, che trasmette ad ogni successiva generazione le istruzioni in codice per sintetizzare le proteine che serviranno al nuovo organismo. Nella cellula, ogni tripletta (una combinazione di 3 nucleotidi) corrisponde a un amminoacido e la sequenza degli amminoacidi forma una proteina.
In quel primo esperimento del 2016, i ricercatori hanno usato il sistema CRISPR per creare un nuovo codice, in cui ad ogni gruppo di nucleotidi non corrisponde un amminoacido, ma un singolo pixel dell’immagine designata. Il risultato è stato un successo: la gif dell’uomo a cavallo ricostruita dal DNA dei batteri era per il 90% identica all’originale. Da allora l’interesse per questa tecnologia non è mai tramontato, anzi il contrario.
Nel mondo moderno, ogni giorno, qualsiasi cosa facciamo, produciamo dati – ne siamo letteralmente sommersi. Nel corso del 2018 l’umanità ha prodotto tanti dati quanti ne sono stati generati nell’intera storia dell’uomo fino al 2017. La pandemia, nel 2020, ha fatto registrare una nuova impennata, portando il numero di byte generati ogni giorno nel mondo alla sconvolgente cifra di 3 quintilioni (un numero a 18 cifre). Presto, quindi, arriveremo a produrre più dati di quanti ne potremo conservare.
È ormai chiaro a tutti che i sistemi classici – nastri magnetici e dispositivi elettronici – non riusciranno a tenere il passo, sia perché la quantità di informazioni generate entro il 2040 sarà tale da superare la disponibilità del silicio, sia perché la loro capacità di archiviazione e durata nel tempo sono limitate. Il DNA invece potrebbe riuscirci.
Sulla durata, la molecola della vita non ha sfidanti: nelle giuste condizioni, rimane stabile anche per migliaia di anni. L’altro punto di forza è la compattezza: ogni singola cellula contiene due metri di DNA impacchettato in un nucleo del diametro di circa 5 micrometri (un micrometro equivale a un milionesimo di metro). Negli ultimi anni, inoltre, gli schemi per la codifica delle informazioni hanno fatto grandi progressi e oggi è possibile memorizzare fino a 17 exabyte (un miliardo di miliardi di byte) in appena un grammo di DNA.
Rimangono però degli ostacoli all’uso di questa tecnologica. Gli hard disk biologici sono ancora nettamente inferiori a quelli elettronici per quanto riguarda la ricerca e lettura dei dati, che è piuttosto lenta e macchinosa. Ed è proprio su questo aspetto che sta lavorando il gruppo coordinato da Tom de Greef della University of Technology (TU) di Eindhoven, con una tecnologia che rende più facile e veloce la consultazione dei dati memorizzati nel DNA.
Oggi esistono delle piattaforme per il sequenziamento che funzionano in maniera veloce e relativamente economica e possono “leggere” l’informazione contenuta nel DNA. Questi metodi si basano quasi sempre su una reazione di PCR (Polymerase Chain Reaction), che amplifica una specifica regione del DNA, così da estrapolare solo l’informazione desiderata – la stessa tecnica è usata ad esempio per amplificare il materiale genetico del virus SARS-CoV-2 nei test molecolari per il COVD.
Il problema della PCR classica è che permette di leggere in maniera efficace solo un “file” alla volta. Se si amplificano più porzioni di DNA nello stesso passaggio, infatti, aumenta la probabilità di errori e le reazioni possono “contaminarsi” l’una con l’altra, producendo pezzi di informazione mischiati e non più coerenti tra di loro.
De Greef e colleghi hanno risposto al problema mettendo a punto un nuovo tipo di PCR che hanno chiamato “termo-confinata”. L’idea è quella di fare avvenire le reazioni simultaneamente, ma in compartimenti fisicamente separati. I ricercatori hanno quindi inserito i singoli file di DNA all’interno di capsule a base di proteine la cui permeabilità dipende dalla temperatura. Le hanno poi mischiate insieme, avviando una unica reazione.
Alle temperature elevate della PCR, la membrana delle capsule diventa completamente impermeabile – in questo modo ogni reazione avviene in un compartimento isolato e non contamina le altre. Questa tecnica permette quindi di amplificare simultaneamente un grande numero di file diversi senza artefatti e “proteggendo” il materiale di partenza, che rimane confinato all’interno della capsula.
I ricercatori hanno anche voluto rendere più facile la ricerca delle informazioni, assegnando a ogni capsula una etichetta fluorescente. Nel futuro, tutte queste capsule potrebbero essere conservate in un centro che avrebbe più o meno l’aspetto e le dimensioni di un normale laboratorio, molto più piccolo dei centri dati che esistono oggi, che occupano molto spazio e consumano tantissima energia. Uno strumento sarebbe in grado di riconoscere il colore associato a ogni capsula e con un braccio robotico la separerebbe dalle altre, leggerebbe l’informazione contenuta al suo interno, e poi la rimetterebbe al suo posto.
Fantascienza? Forse ancora per poco. “Resta solo da aspettare che i costi per la sintesi del DNA scendano ancora di più”, ha commentato de Greef. Ma nella migliore delle ipotesi, conclude il ricercatore, il primo centro al mondo per l’archiviazione dati nel DNA potrebbe vedere la luce già nei prossimi 5-10 anni.