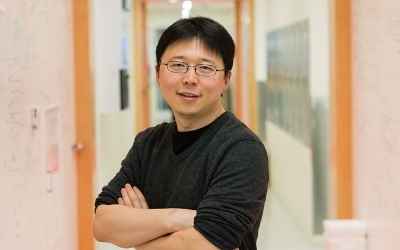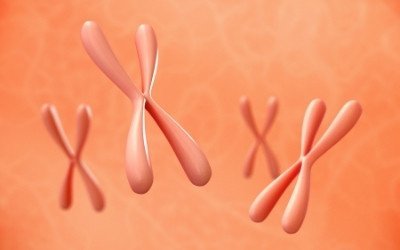Editing genomico
Editing genomico: che cos'è e a cosa serve? Sarà la terapia del futuro?
L’editing genomico è una tecnologia altamente innovativa che funziona come un “correttore di bozze” del DNA: interviene in maniera precisa per trovare e correggere gli errori genetici all’interno dell’intero genoma. Molti considerano l’editing genomico come la terapia genica del futuro, visto che permetterebbe di correggere un gene difettoso direttamente là dove si trova senza doverne fornire una copia sana dall’esterno.
Una tecnica da Nobel: CRISPR
La vera rivoluzione in questo campo è arrivata nel 2012 con la scoperta del sistema Crispr-Cas9, che ha messo in secondo piano i sistemi di editing denominati nucleasi a dita zinco (zinc-finger nucleases), meganucleasi e TALEN che erano stati utilizzati fino ad allora dai ricercatori di tutto il mondo. CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, espressione traducibile in italiano con brevi ripetizioni palindrome raggruppate e separate a intervalli regolari) ha dimostrato, fin da subito, una potenzialità e una versatilità fino a poco prima inimmaginabili: qualunque tipo di cellula vegetale, animale, inclusa quella umana, può essere modificata geneticamente e la correzione può avvenire anche per un singolo errore, e ovunque nel genoma. Inoltre, questa tecnica è facile da utilizzare, veloce ed economica, tutti fattori che contribuiscono ad ampliarne le potenzialità in ambito terapeutico. Una rivoluzione che ha premiato le sue scopritrici e autrici dell'ormai famoso studio pubblicato su Science nel 2012 - Emmanuelle Charpentier, Direttrice del Max Planck Unit for the Science of Pathogens a Berlino, e Jennifer A. Doudna, Professoressa all’University of California (Berkeley) - a vincere il Premio Nobel per la Chimica 2020 per lo “sviluppo di un metodo di editing genomico” basato su CRISPR.
CRISPR è l’acronimo di “Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats”, ovvero sequenze geniche che si ripetono a intervalli regolari. A CRISPR sono associati i geni Cas ("CRISPR associated", da cui deriva "Crispr-Cas9") che codificano enzimi capaci di tagliare il DNA. Il DNA non viene tagliato in modo casuale, ma in un punto preciso grazie alla presenza di un RNA guida.
Questo sistema è stato originariamente scoperto nei batteri, nei quali agisce come arma di difesa contro i virus - un po' come il sistema immunitario umano - e funziona in maniera molto semplice ma con grande efficienza. Il sistema CRISPR si basa sulla combinazione di due elementi: un enzima Cas e un RNA guida che si appaia al DNA del virus per indicare a Cas il punto in cui tagliare. Come nel caso della terapia genica, anche la strategia di editing basata su CRISPR può essere somministrata in vivo (direttamente nell'organismo) o ex vivo (all'esterno, su cellule vive prelevate dell'organismo).
Ad oggi la ricerca nell’ambito dell’editing genomico spazia dalle malattie genetiche, in particolar modo quelle rare (come la distrofia muscolare di Duchenne, la beta-talassemia e la fibrosi cistica), ai tumori, passando per le malattie neurologiche (Alzheimer e Parkinson), fino alle malattie infettive (HIV). L’utilizzo di CRISPR è inoltre in studio nel campo degli xenotrapianti, in particolare degli organi suini, per la terapia di malattie umane.
Il pioniere sino-americano, celebre per aver adattato CRISPR alle cellule umane, ha illustrato le sue linee di ricerca al congresso annuale dei genetisti italiani
Feng Zhang è considerato un mago dell’innovazione biotech. A 24 anni ha dato un contributo fondamentale all’invenzione dell’optogenetica, che serve a controllare il funzionamento delle cellule attraverso gli impulsi luminosi. A 32 ha capito come far funzionare il sistema batterico CRISPR nei mammiferi, il cui DNA è compartimentato e organizzato ben diversamente rispetto a quello dei microrganismi. Oggi di anni ne ha 40 e nelle provette del suo laboratorio, al Broad Institute di Boston, continuano a bollire idee originali. “Spero che troverete interessanti i progetti che illustrerò”, ha esordito lo scorso 24 settembre, quando si è collegato da remoto al meeting dell’Associazione Genetica Italiana. La sua lezione non ha deluso le aspettative.
- Di: Anna Meldolesi
L’editing genomico contro uno dei virus più temuti dell’età contemporanea: negli USA i primi semafori verdi per EBT-101, sviluppata con la collaborazione della Statale di Milano
I ricercatori della Lewis Katz School of Medicine della Temple University di Philadelphia hanno perfezionato la tecnologia di editing genomico basata su CRISPR con l’obiettivo di trattare l'infezione cronica da HIV. Questo ha portato alla recente approvazione da parte della Food and Drug Administration (FDA) della domanda come “Investigational New Drug” (IND) per la terapia sperimentale chiamata EBT-101, sviluppata dalla biotech Excision BioTherapeutics. Questa autorizzazione permette all’azienda di iniziare uno studio clinico di Fase I/II per valutare la sicurezza, la tollerabilità e l'efficacia della terapia in persone che convivono con il virus dell'immunodeficienza umana di tipo 1. Come spiegato sul comunicato stampa, l’inizio dello studio clinico è previsto entro la fine di quest’anno.
- Di: Rachele Mazzaracca
Le terapie basate sull’innovativo sistema di editing genomico entrano in clinica, ma la rottura programmata del DNA potrebbe causare anomalie geniche che vanno approfondite
Uno studio pubblicato su Nature Genetics ha identificato un potenziale ostacolo all’applicazione terapeutica della tecnica di editing genomico: le rotture del doppio filamento di DNA introdotte dal sistema CRISPR potrebbero provocare cromotripsi. Si tratta di un fenomeno genetico causato dal riarrangiamento disordinato dei cromosomi frammentati ad opera dei meccanismi cellulari di riparazione del DNA. Questo fenomeno è associato a rare malattie congenite ed è comune nel cancro. Fortunatamente nella maggior parte dei casi le cellule che subiscono questa alterazione muoiono, ma la questione merita un attento approfondimento da parte della comunità scientifica.
- Di: Rachele Mazzaracca
La natura offre un ricco repertorio di enzimi e i laboratori fanno a gara per perfezionarli. Ecco gli ultimi arrivati nella cassetta degli attrezzi per l’editing genomico
Dopo che Jennifer Doudna ed Emmanuelle Charpentier hanno inventato CRISPR, meritandosi il Nobel, altri ricercatori si sono dati da fare per reinventarla, sviluppandone nuove varianti che promettono di fare più cose e farle meglio. Una delle menti più creative impegnate in questa attività di riprogettazione molecolare è il ricercatore di origine cinese Lei Stanely Qi. Il suo laboratorio all’Università di Stanford è diventato una miniera di novità. Suo è stato il primo modello di CRISPR con le forbici disattivate deliberatamente, per trovare il bersaglio senza tagliare (dCas). Sua è anche l’ultima arrivata: una Cas miniaturizzata per poter entrare più facilmente nelle cellule di cui si vuole modificare il genoma.
- Di: Anna Meldolesi
Gli scienziati hanno usato la tecnologia di editing genomico per bloccare con successo la trasmissione del Coronavirus nelle cellule umane in vitro
Secondo una ricerca australiana pubblicata a luglio su Nature Communcations, CRISPR potrebbe essere utile anche contro la trasmissione del coronavirus SARS-CoV-2. Stando ai test di laboratorio, CRISPR si lega a delle specifiche sequenze di RNA virale, degradando i segmenti necessari alla replicazione del virus all’interno delle cellule umane. Considerata la recente e, purtroppo, veloce comparsa di nuove varianti del coronavirus, è necessario trovare approcci innovativi in grado di superare i problemi che possono rallentare la ricerca: l’editing genomico potrebbe essere un’interessante opzione, anche se è ancora presto per parlare di applicazione clinica.
- Di: Rachele Mazzaracca
Un comitato ad hoc dell’agenzia delle Nazioni Unite ha passato in rassegna principi etici e strumenti regolatori, mettendoli alla prova con alcuni scenari ipotetici
Due anni di consultazioni, 18 esperti in rappresentanza di tutte le aree geografiche, oltre 150 pagine di analisi. L’atteso rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sull’editing del genoma umano è stato pubblicato il 12 luglio e si articola in tre parti: “Un quadro per la governance”, “Raccomandazioni” e “Position Paper”. Pur non essendo vincolanti, le indicazioni dell’OMS sono destinate a influenzare sia i governi che la comunità scientifica, poiché rappresentano il primo tentativo di mettere ordine su scala globale in un settore di ricerca tanto promettente quanto delicato. Non regole, ma coordinate per una roadmap che tiene conto di principi etici largamente condivisibili e approcci normativi concretamente utilizzabili.
- Di: Anna Meldolesi
Agenda
News da CRISPeR MANIA
a cura di Anna Meldolesi