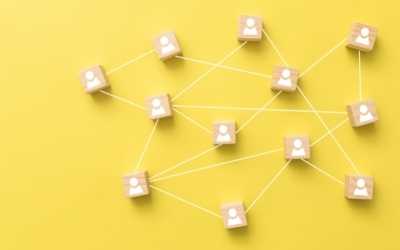Terapia genica
Trattare le malattie mirando alle basi genetiche
COME FUNZIONA LA TERAPIA GENICA?
Tra le diverse terapie avanzate e di precisione, la terapia genica è una delle prime ad essere state ideate e ha l’obiettivo di trattare una patologia mirando direttamente alle sue basi genetiche. Il concetto base di questa strategia terapeutica è di fornire all’organismo una copia corretta del gene difettoso o un altro gene che possa compensarne il malfunzionamento nelle cellule colpite dalla malattia.
Esistono due principali modalità di somministrazione per la terapia genica:
- in vivo: il “gene terapeutico” viene somministrato direttamente nell’organismo del paziente, mediante un’iniezione per via locale (organo bersaglio) o per via sistemica (nella circolazione sanguigna);
- ex vivo: la correzione avviene all’esterno dell’organismo del paziente. Infatti, le cellule bersaglio vengono prelevate dal paziente, modificate geneticamente, e reintrodotte nel paziente stesso.
Per veicolare il “gene terapeutico” all’interno delle cellule o dell’organismo si utilizzano generalmente dei vettori virali: ad oggi i più utilizzati sono i vettori virali adeno-associati (AAV).
Il potenziale della terapia genica è di enorme portata poiché potrebbe rappresentare una cura per tutta una serie di gravissime malattie per cui oggi non esistono valide opzioni terapeutiche o che richiedono terapie croniche. Ad oggi la ricerca nell’ambito della terapia genica spazia dalle malattie genetiche, in particolar modo quelle rare, al cancro, passando per le malattie autoimmuni e le malattie infettive.
Il concetto di terapia genica nasce alla fine degli anni ‘80 con le nuove tecniche del DNA ricombinante che permettono di costruire pezzi di DNA contenenti sequenze geniche desiderate. Ma è solo negli ultimi anni, con il sequenziamento del genoma e l’avanzare delle biotecnologie, che si sono cominciati a vedere i primi importanti risultati nelle sperimentazioni sull’uomo e le prime terapie geniche autorizzate dall’European Medicines Agency (EMA) in Europa e della Food and Drug Administration (FDA) negli Stati Uniti. In questo ambito l’Italia ha una posizione di eccellenza a livello internazionale: sono diverse le terapie avanzate frutto di ricerche all'avanguardia "made in Italy".
Pubblicato uno studio che mette in luce i risultati di tre diversi trial per questa rara malattia. I dati confermano che la sicurezza ed efficacia della terapia sperimentale si mantiene fino a nove anni
Dinnanzi a una nuova terapia genica le aspettative sono sempre alte visto che punta alla possibilità di trattare in via definitiva patologie ancora prive di una cura. Ma la domanda che molti - e specialmente coloro che hanno il compito di valutare tali innovative terapie - si pongono è quanto a lungo durerà l’effetto di tali trattamenti. La risposta più bella sarebbe “per sempre” ma, trattandosi di una frontiera della medicina relativamente nuova e per lo più destinata a malattie che riguardano poche persone nel mondo, mancano spesso i dati a lungo termine. Per questo sono stati accolti con grande entusiasmo i risultati positivi, pubblicati sulla rivista Molecular Therapy, riguardo a nove anni di follow-up su pazienti trattati con una terapia genica sperimentale per il deficit di decarbossilasi degli L-aminoacidi aromatici (AADC).
- Di: Enrico Orzes
Una partnership tra NIH, FDA, aziende private e organizzazioni non-profit ha favorito la nascita di un programma per lo sviluppo di terapie geniche rivolte a diverse patologie
Nella medicina moderna uno dei termini che ricorrono con più frequenza è “multidisciplinare”, inteso come un approccio che metta insieme le competenze di ambiti di studio diversi per affrontare una patologia, o meglio per farsi carico correttamente dei pazienti dalla diagnosi sino all’impostazione della terapia e al successivo follow-up. Ma guardando ai percorsi di ricerca necessari per sviluppare le nuove terapie avanzate, il significato di questo termine può essere interpretato in maniera più ampia e coinvolgere non solo il mondo della ricerca e della clinica, ma anche quello dell’impresa e l’universo delle associazioni. Ed è esattamente questo che si sta cercando di fare oltreoceano con la nascita di Bespoke Gene Therapy Consortium (BGTC).
- Di: Enrico Orzes
Qualche anno fa la storia di Hassan aveva fatto il giro del mondo: la terapia genica gli ha salvato la vita e oggi sta bene. A distanza di 5 anni la pelle trapiantata è sana, ce ne parla Michele De Luca
Nel 2015 Hassan, un bambino siriano di 7 anni affetto da epidermolisi bollosa giunzionale, è stato ricoverato nel centro ustioni dell’ospedale di Bochum in Germania per le ferite causate dalla rara patologia genetica che colpisce gli epiteli, ulteriormente aggravate da una infezione così grave da dovergli indurre il coma farmacologico. I medici, dopo aver fallito nel curare il piccolo paziente con le terapie disponibili, tentarono un’ultima cosa: contattarono il prof. Michele De Luca, Direttore del Centro di Medicina Rigenerativa (CMR) “Stefano Ferrari” dell’Università di Modena e Reggio Emilia e Direttore Scientifico di Holostem Terapie Avanzate, per produrre dei lembi di pelle da trapiantare in cui il gene difettoso era stato corretto. A distanza di 5 anni e 5 mesi, Hassan sta bene e la sua nuova pelle cresce con lui.
- Di: Rachele Mazzaracca
Gli Stati Uniti si apprestano all’avvio di uno studio clinico per una terapia genica da somministrare come un aerosol. Il trattamento è pensato per molti pazienti, indipendentemente dalla loro mutazione
Un antico detto popolare contenuto in un libro di almanacchi e filastrocche invitava a considerare poco sano il bambino la cui fronte “sa da sale quando la sia bacia”. I nonni dei nostri nonni, pur senza conoscerne l’origine genetica avevano compreso il principale problema legato alla fibrosi cistica, una rara malattia genetica contraddistinta proprio da un aumentata secrezione di sali, con un muco così vischioso da ostruire i dotti di organi vitali come i polmoni o il pancreas. Sebbene oggi esistano alcune opportunità di trattamento, manca ancora una cura specifica per questa patologia, e ciò genera aspettative molto alte intorno alla terapia genica.
- Di: Enrico Orzes
Lo studio clinico è stato condotto all’Istituto San Raffaele-Telethon di Milano. I risultati preliminari di sicurezza ed efficacia sono positivi: i piccoli pazienti crescono e stanno bene
Se la medicina fosse intesa come una partita a Risiko tra la malattia e i medici o i ricercatori, i risultati pubblicati qualche giorno fa su The New England Journal of Medicine sulla terapia genica sperimentale per la sindrome di Hurler - una grave forma di mucopolisaccaridosi - rappresenterebbero un grande passo avanti per il raggiungimento dell’obiettivo finale: sconfiggere la malattia. Infatti, gli otto bambini trattati con l’innovativa terapia messa a punto dai ricercatori dell’Istituto San Raffaele-Telethon di Milano (SR-Tiget) hanno mostrato risultati clinici molto incoraggianti: dopo due anni stanno tutti bene e hanno raggiunto tappe importanti del loro percorso di sviluppo.
- Di: Enrico Orzes
I risultati ottenuti in tre pazienti italiane sono entusiasmanti. Il percorso dello studio clinico è ancora lungo, andrà avanti fino al 2026, ma le premesse sono ottime
È di quest’estate la notizia delle prime tre pazienti affette dalla sindrome di Crigler-Najjar trattate in Italia, all’Ospedale di Bergamo, con una terapia genica sperimentale. Il trattamento è avvenuto nell’ambito dello studio clinico internazionale “CareCN”, coordinato da Généthon e finanziato dalla Comunità Europea all’interno del programma Horizon 2020 in collaborazione con la rete “CureCN”, e con il contributo fondamentale dell’associazione CIAMI onlus. Ad oggi sono stati trattati solo cinque pazienti in tutta Europa e le tre pazienti italiane hanno mostrato i migliori risultati di efficacia. Ce ne parlano il prof. Lorenzo D’Antiga e il prof. Nicola Brunetti-Pierri, coordinatori dello studio clinico rispettivamente presso l’Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli.
- Di: Giulia Virtù
Agenda
News da CRISPeR MANIA
a cura di Anna Meldolesi