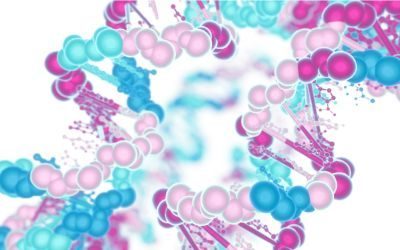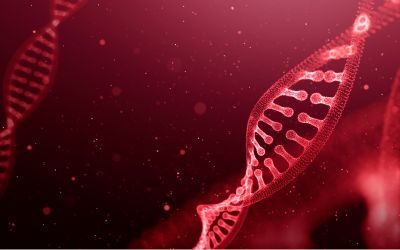News
Terapia genica per le mutazioni nel gene dell’otoferlina
Ripristinato l’udito in una bambina inglese di 18 mesi sorda dalla nascita. La notizia ha fatto velocemente il giro del mondo ma, attenzione, non è una terapia utilizzabile in tutti i casi di sordità
Opal Sandy è nata priva della possibilità di udire i suoni in seguito a una neuropatia uditiva di origine genetica (è opportuno non dimenticare quest’ultimo particolare): si tratta di una condizione capace di interrompere la trasmissione degli impulsi nervosi che dall’orecchio interno giungono al cervello. Fortunatamente, grazie all’infusione di una terapia genica sperimentale effettuata nell’ambito di uno studio clinico, Opal ha potuto sentire le voci di mamma e papà e adesso, addirittura, si diverte a giocare con dei tamburi giocattolo. La notizia di questo importante risultato è rimbalzata sui maggiori organi di stampa, non sempre in maniera corretta, quasi a voler suggerire che possa presto essere disponibile una terapia “per far udire i sordi”. Ma è davvero così? Prima di saltare a facili conclusioni occorre riflettere su alcuni particolari non trascurabili, Osservatorio terapie Avanzate fa un po’ di chiarezza.
- Di: Enrico Orzes
Rigenerare il cuore per contrastare le patologie cardiovascolari
La ricerca della dottoressa Paola Cattaneo, del Centro Cardiologico Monzino di Milano, su nuove possibili strategie per la rigenerazione cardiaca ha ricevuto il prestigioso ERC Starting Grant
Il tracciato normale di un elettrocardiogramma - in assenza di anomalie cardiache - ripropone ciclicamente il medesimo andamento che descrive le fluttuazioni nei potenziali d’azione delle singole fibre del cuore. Quel peculiare disegno è la rappresentazione di ogni battito che il cuore produce. Ma le cellule del cuore - i cardiomiociti – con il tempo invecchiano, perdono la loro capacità di contrarsi e, infine, muoiono come tutte le altre cellule del corpo: ciò è causa di patologie potenzialmente gravi, come lo scompenso cardiaco. La ricerca scientifica si sta adoperando per capire come interrompere - o correggere - tale processo di decadimento e, tra gli approcci di terapia genica in fase di sviluppo preclinico, c’è quello ideato da Paola Cattaneo, ricercatrice di ruolo del CNR e Group leader presso l’IRCCS Centro Cardiologico Monzino.
- Di: Rachele Mazzaracca
Studi clinici: dallo scorbuto al consenso informato
Comprendere cosa sono e come funzionano i trial è fondamentale, sia per decidere se partecipare che per capire come funziona la ricerca clinica
Come ogni anno dal 2014, il 20 maggio si celebra la Giornata Mondiale degli studi clinici: un’occasione per “fermarsi a riflettere, riconoscere e ammirare tutto ciò che è stato realizzato grazie alle sperimentazioni cliniche e alle persone che ci sono dietro”, come spiegato sul sito dedicato dall’Association of Clinical Research Professionals (ACRP) che la organizza. La data è stata scelta in onore del giorno in cui - nel lontano 1774 - James Lind, chirurgo di bordo della Marina Reale britannica, avviò quello che viene spesso considerato il primo studio clinico controllato. Nello specifico, si trattava di studiare gli effetti di diversi trattamenti sullo scorbuto. Ma cos’è un trial clinico? Cosa vuol dire randomizzato? E a cosa serve il placebo? Osservatorio Terapie Avanzate ripercorre la storia degli studi clinici, dagli studi pionieri fino a quelli attuali, illustrandone obiettivi, protocolli e termini in maniera semplice ed esaustiva, così da mettere a disposizione di tutti gli strumenti per comprendere il reale significato di una sperimentazione clinica.
- Di: Rachele Mazzaracca
Terapia genica per l’emofilia B: un secondo ok negli Stati Uniti
Fidanacogene elaparvovec-dzkt si aggiunge alla lista delle terapie avanzate approvate oltreoceano e rappresenta una nuova opzione terapeutica per i pazienti emofilici
Sono diventate due le terapie geniche per l’emofilia B disponibili per i pazienti statunitensi: etranacogene dezaparvovec (nome commerciale Hemgenix) , autorizzata nel 2022 oltreoceano e nel 2023 in Europa, e fidanacogene elaparvovec-dzkt (nome commerciale Beqvez), che ha ottenuto il via libera dalla Food and Drug Administration (FDA) a fine aprile. Pfizer, l’azienda produttrice del trattamento, ha ottenuto l’autorizzazione grazie ai risultati dello studio di Fase III BENEGENE-2, che ha valutato la sicurezza e l'efficacia di Beqvez in pazienti maschi adulti con diagnosi di emofilia B da moderata a grave (con attività circolante del fattore IX pari o inferiore al 2%), di età compresa tra i 18 e i 65 anni.
- Di: Redazione
Agenda
News da CRISPeR MANIA
a cura di Anna Meldolesi