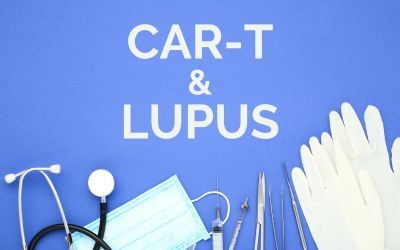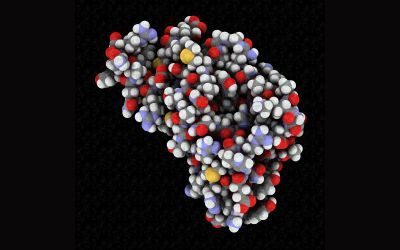News
RNA therapies: buoni risultati preliminari per la malattia di Huntington
I dati ad interim degli studi di Fase I/II su AMT-130 hanno evidenziato un rallentamento dell’80% nella progressione di malattia e una diminuzione dei livelli dei neurofilamenti
Quando si entra nel campo della malattia di Huntington bisogna fare attenzione a dove poggiare i piedi per non sprofondare: infatti, se ogni malattia fosse un terreno da attraversare (al di là del quale c’è una terapia efficace), alcune sarebbero strade di campagna, altre delle autostrade, altre ancora un deserto. La Huntington è una palude dove perdersi è all’ordine del giorno. Ne sono consce le aziende farmaceutiche che, a mo' di esploratori, hanno inviato i loro prodotti sulla strada dello sviluppo clinico, finora senza troppo successo. Occorre perciò prudenza anche di fronte agli incoraggianti risultati preliminari ottenuti da AMT-130, una terapia su RNA sviluppata da UniQure e in valutazione con due studi clinici di Fase I/II.
- Di: Enrico Orzes
CAR-T: trattata in Germania un’adolescente con lupus
Le sue condizioni erano disperate, i reni erano al collasso e non c’erano altre soluzioni terapeutiche utili. Dopo le CAR-T, la quindicenne Uresa sta bene
Il suo caso, pubblicato sulla rivista The Lancet, potrebbe essere destinato a entrare nella storia della medicina, come il precedente di Emily Whitehead, la bambina divenuta il simbolo del successo delle terapie a base di cellule CAR-T. Mentre Emily era affetta da una grave forma di leucemia (storia raccontata nel podcast di OTA “Reshape – un viaggio nella medicina del futuro”) - indicazione per cui le CAR-T sono state approvate prima negli Stati Uniti e poi in Europa - Uresa soffre di lupus eritematoso sistemico (LES), una patologia cronica autoimmune le cui manifestazioni danneggiano tutto l’organismo. La differenza non è poca perché il caso di Uresa trascina le CAR-T in un universo parallelo a quello delle malattie oncologiche, verso un probabile trattamento di disturbi autoimmuni che interessano milioni di persone nel mondo.
- Di: Enrico Orzes
L’editing dell’epigenoma prende di mira le malattie da prioni
Ricercatori del MIT e di Harvard hanno creato un nuovo strumento per silenziare i geni senza modificarne la sequenza e lo stanno usando contro una patologia neurodegenerativa fatale
Guidati da Sonia Vallabh del Broad Institute e da Jonathan Weissman del Whitehead Institute del MIT (Stati Uniti), un team di scienziati ha messo a punto una tecnologia chiamata CHARM (Coupled Histone tail for Autoinhibition Release of Methyltransferase), che tramite diversi meccanismi è in grado di spegnere l'espressione del DNA. I risultati, pubblicati a fine giugno su Science, puntano di nuovo l’attenzione sull’editing dell’epigenoma (ne abbiamo parlato recentemente qui) e stavolta l’obiettivo sono le malattie da prioni, in cui il ripiegamento errato di alcune proteine porta alla degenerazione dei neuroni e alla loro morte che lascia dei veri e propri buchi nel cervello, una caratteristica della malattia.
- Di: Rachele Mazzaracca
Una terapia genica per la paraplegia spastica
È stata somministrata, all’interno di uno studio clinico condotto in Canada, a un bambino di 4 anni affetto da una malattia ultra-rara che provoca la degenerazione del tratto corticospinale
L’articolo pubblicato a fine giugno sulle pagine della rivista Nature Medicine non racconta solo di una terapia genica sviluppata in maniera personalizzata, in tempi brevi e dal costo di quasi quattro milioni di dollari, per uno dei circa cento bambini al mondo affetti da una gravissima malattia neurodegenerativa - la paraplegia spastica ereditaria di tipo 50 - ma accende una lampadina sulle opportunità e sulle criticità legate allo sviluppo di trattamenti innovativi destinati alla cura di malattie ultra-rare (di cui avevamo già parlato anche qui). Nell’arco di tre anni, infatti, i ricercatori sono arrivati a disporre di un farmaco sperimentale tagliato su misura sulle caratteristiche cliniche del giovane. Ciononostante, affinché il modello sia replicabile, bisognerà trovare soluzioni a degli interrogativi ancora aperti.
- Di: Enrico Orzes
Agenda
News da CRISPeR MANIA
a cura di Anna Meldolesi