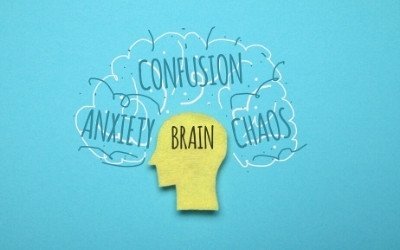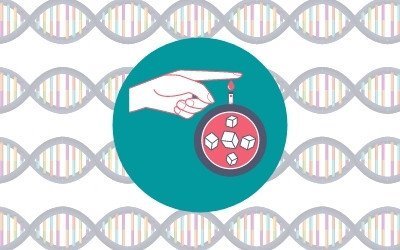News
Organoidi. Ricreare la pelle umana in laboratorio
Generare organoidi che riproducono la complessità della pelle umana partendo da cellule staminali pluripotenti umane. Il successo arriva dagli Stati Uniti ed è stato pubblicato su Nature
Se avete visto il film di Pedro Almodovar “La pelle che abito” probabilmente non avrete dimenticato la situazione grottesca intorno a cui ruotava la trama del film, ma se vi concentrate in particolare sul ruolo del protagonista ricorderete che si trattava di un medico impegnato nello studio della pelle, anzi nella ricerca di un modo per sintetizzare una pelle artificiale. Nell’articolo pubblicato a inizio giugno sulle pagine della rivista Nature, il prof. Karl R. Koehler e il suo gruppo di ricerca sono riusciti nella medesima impresa del protagonista del film, ricreando la pelle umana a partire dalle cellule staminali. E senza le stravaganti finalità messe in opera nella pellicola.
- Di: Enrico Orzes
Terapie digitali. Dalle app un supporto per la salute mentale in tempi di COVID-19
L’impatto psicologico della pandemia è stato notevole: un recente studio ha evidenziato come delle app dedicate alla salute mentale avrebbero effetti positivi su depressione e ansia
Le conseguenze della pandemia COVID-19 sulla salute mentale sono rilevabili in tutto il mondo e vanno dallo stress legato alla paura di infettarsi, finire in quarantena o in autoisolamento, fino alle esperienze traumatiche di perdita - di vite umane e di mezzi di sostentamento - e di repentino e spesso drastico cambiamento delle abitudini. Mentre rimangono molte incertezze su come la pandemia evolverà nel prossimo futuro, è sicuro che l'impatto psicosociale sarà importante e duraturo. Ma la digital health potrebbe venire in aiuto. Come riportato lo scorso maggio su JAMA Psychiatry, un gruppo di app, raggruppate sotto il nome di IntelliCare, ridurrebbero significativamente l’ansia e la depressione.
- Di: Rachele Mazzaracca
Terapia genica. Eventi avversi gravi sollevano il dibattito su dosaggio e sicurezza
Gli esperti si interrogano intorno a una serie di eventi avversi fatali avvenuti con alte dosi di una terapia genica per la miopatia miotubulare legata all'X
La scienza si sa, procede per passi. Avanza piano piano con esperimenti che possono confermare un’ipotesi o meno. Capita che i risultati siano positivi e si proceda verso l’obiettivo finale che, in campo biomedico, è sempre una terapia o, comunque, un miglioramento della qualità di vita dei pazienti. Capita però (anche più spesso) che questa verifica dell’ipotesi fallisca e che proprio da lì si riparta per migliorare e imboccare la strada giusta. Gli intoppi avvengono per lo più durante la fase preclinica, quella che si svolge in laboratorio, ma possono avvenire anche nella fase clinica, sugli esseri umani. È quello che è successo di recente durante una sperimentazione clinica di Fase I/II, il cui obiettivo era di testare alte dosi di una terapia genica per la miopatia miotubulare legata all'X (XLMTM), una rara malattia neuromuscolare che colpisce i neonati.
- Di: Cristina Tognaccini
CRISPR scende in campo contro le malattie autoimmuni
Una ricerca preclinica condotta sulle cellule T regolatorie (Treg) dimostra l’utilità della tecnica per trovare una soluzione a patologie come il diabete di tipo 1
Non è più un mistero per nessuno che i linfociti T stiano diventando gli indiscussi protagonisti della medicina del prossimo futuro e il successo delle terapie CAR-T costituisce una solida prova del loro valore. Tuttavia, la comprensione del ruolo dei linfociti T passa attraverso la realizzazione che si tratta di un poliedrico insieme di cellule, altamente differenziate. La loro stessa eterogeneità è il punto su cui fare leva per poterli impiegare anche contro malattie autoimmuni quali il diabete e, come dimostrato da uno studio pubblicato su Science Translational Medicine, la tecnica di editing del genoma nota come CRISPR potrebbe essere la leva giusta per questa operazione.
- Di: Enrico Orzes
Agenda
News da CRISPeR MANIA
a cura di Anna Meldolesi