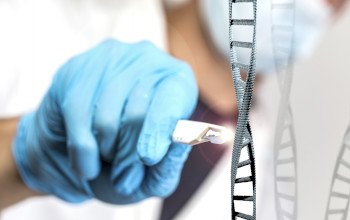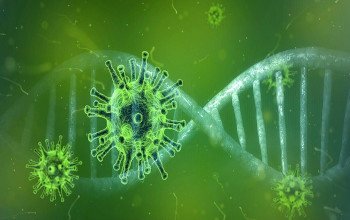News
Terapia genica. Una nuova ingegnosa tecnologia per controllarne il dosaggio
Ricercatori statunitensi hanno dimostrato, su modelli animali, che è possibile modulare la terapia genica. Offrendo così una soluzione al problema di sicurezza.
Un po’ come un rubinetto che ci permette di regolare il flusso di acqua desiderato, così un gruppo di ricercatori dello Scripps Research in Florida, ha messo a punto un “interruttore molecolare” che, se incorporato nelle terapie geniche, potrebbe permettere di regolarne l’attività. La ricerca preclinica, pubblicata lo scorso dicembre su Nature Biotechnology, è stata condotta su modelli animali e ha fornito risultati positivi, che se confermati in ulteriori studi potrebbero offrire la prima soluzione per regolare la dose dei geni terapeutici. Risolvendo cosi un problema di sicurezza che finora ha limitato la diffusione di nuove terapie geniche.
- Di: Cristina Tognaccini
CAR-T: sfruttare le nanoparticelle per produrre una versione meno tossica
Una ricerca preclinica ha mostrato che utilizzare le nanoparticelle per veicolare l’RNA messaggero attraverso la membrana delle cellule T potrebbe portare a minori effetti collaterali
Punti di forza e punti critici sono intrinsechi di ogni fatto, persona o cosa. Le terapie CAR-T non escluse. Da quando sono arrivate sul mercato statunitense nel 2017 infatti, la comunità scientifica oltre a decantarne i vantaggi, ha continuato a lavorarci per migliorarle ulteriormente ed estenderne ancora le potenzialità. Un punto particolarmente importante su cui diversi gruppi di ricerca sono impegnati è la sicurezza, che può ancora essere migliorata. Proprio su questo fronte alcuni scienziati dell’Università della Pennsylvania hanno sviluppato di recente un sistema sperimentale per produrre cellule CAR-T meno tossiche, sfruttando per la manipolazione genetiche nanoparticelle che veicolano l'RNA messaggero (mRNA), anziché il classico virus contenente il DNA.
- Di: Cristina Tognaccini
CRISPR. Un correttore ad alta efficienza testato in organoidi per la fibrosi cistica
Scienziati olandesi hanno messo a punto e studiato una versione di base-editing che ha dato buoni risultati in quattro mutazioni in modelli di organoidi creati da pazienti.
Utilizzare una versione di CRISPR più precisa e sicura su organoidi derivati da pazienti affetti da fibrosi cistica per correggere quattro mutazioni che provocano questa complessa patologia. In estrema sintesi è questo ciò che un gruppo di ricercatori olandesi dell’Hubrecht Institute e dell’Università di Utrecht è riuscito a fare ed è stato descritto nell’articolo scientifico pubblicato lo scorso 20 febbraio sulla rivista Cell Stem Cell. Una ricerca affascinante che ha per protagonisti CRISPR, il più sofisticato strumento di editing del genoma, la fibrosi cistica, la più diffusa malattia genetica a prognosi severa, e gli organoidi, il paradigma di modello cellulare più studiato degli ultimi anni.
- Di: Enrico Orzes
Coronavirus. Dagli antivirali alle staminali: oltre 80 i trial clinici per testare possibili trattamenti
Farmaci antivirali, antimalarici, medicina tradizionale cinese e, infine, anche le cellule staminali mesenchimali. Ma l’OMS chiede rigore e sottolinea la necessità di seguire percorsi trasparenti e secondo le regole.
Il numero dei contagiati da coronavirus 2019 n-CoV (ora ufficialmente rinominato SARS-CoV-2) nel mondo, e ormai anche in Italia, cresce di giorno in giorno e mentre i medici e il personale sanitario stanno mettendo in atto le misure a disposizione per combattere e arginare l’infezione, i ricercatori di tutto il mondo sono impegnati nel trovare una terapia efficace e mettere a punto un vaccino. Ricerche che richiederanno tempi dilatati, soprattutto per il vaccino (la stima è di almeno 12-18 mesi), poiché dovranno ottemperare agli standard di sicurezza ed efficacia imposti dalle autorità regolatorie. Nel frattempo stanno fiorendo gli studi clinici imperniati su possibili soluzioni terapeutiche.
- Di: Enrico Orzes
Agenda
News da CRISPeR MANIA
a cura di Anna Meldolesi