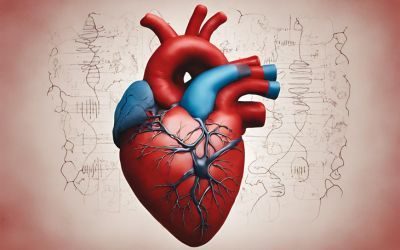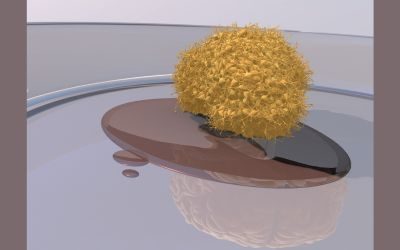News
OMaR diventa media partner di EUPATI
Dopo l’intesa con Osservatorio Terapie Avanzate, questo nuovo accordo ha l’obiettivo di portare un’informazione chiara e accurata sui trial clinici e sullo sviluppo di farmaci
Solo pochi mesi dopo l’annuncio della collaborazione dell’Accademia del Paziente Esperto EUPATI (AdPEE) con Osservatorio Terapie Avanzate (OTA) per realizzare attività di formazione e informazione sul tema della ricerca e sviluppo delle terapie avanzate, arriva anche l’accordo con Osservatorio Malattie Rare (OMaR). Lo scopo di questo protocollo di intesa è quello di rendere i cittadini, e in modo particolare i pazienti e i caregiver, consapevoli di come funziona la ricerca clinica e il conseguente iter che porta una terapia dal laboratorio fin dentro la loro vita.
- Di: Redazione
Anche il Sud del mondo aspetta le terapie avanzate
I ricercatori dei Paesi a basso e medio reddito stanno cercando di portare le terapie avanzate alle persone che ne hanno bisogno, con la speranza di ridurre i costi optando per la produzione locale
L’innovazione costa. Portare una terapia genica o cellulare sperimentale dal bancone del laboratorio al letto del paziente richiede tempo, ma anche grossi investimenti (e un pizzico di fortuna). Quando una terapia supera gli studi clinici e i risultati supportano un suo utilizzo in clinica si passa alla definizione del prezzo, che sarà a carico dei sistemi sanitari, delle assicurazioni sanitarie o del paziente stesso. Questo si traduce nell’impossibilità delle persone dei Paesi più a basso reddito di sottoporsi a queste terapie, spesso salvavita, proprio a causa della spesa elevata. Un modo per ovviare il problema è quello di cercare di ridurre i costi e una delle strategie prevede la produzione di versioni “locali” delle terapie avanzate, ma a livello normativo e produttivo le sfide sono tante. Un articolo pubblicato su Nature Biotechnology ha fatto un’analisi della situazione, riportando alcuni esempi.
- Di: Rachele Mazzaracca
Terapia genica: in avvio un nuovo trial che mira al cuore
Lo studio clinico di Fase II sarà condotto negli Stati Uniti per valutare l’efficacia e la sicurezza di una nuova strategia che trasporta il gene per una proteina terapeutica direttamente nel cuore
Solo pochi animali, da adulti, conservano la capacità di rigenerare spontaneamente il tessuto cardiaco. Negli esseri umani il cuore non si rigenera, o lo fa a un ritmo così lento da non riuscire a contrastare il danno causato da patologie come l’infarto o l’insufficienza cardiaca. Ma le terapie avanzate possono agire su un cuore danneggiato, rigenerando il tessuto perso o invertendo la traiettoria della malattia. Questa è la scommessa di AskBio, l’unità di terapia genica di Bayer, che sta sperimentando una terapia genica basata su un virus adeno-associato (AAV) per ripristinare la funzione cardiaca. I risultati del trial di Fase I sono stati presentati al Congresso Annuale dell’American Heart Association, e ora è in avvio lo studio di Fase II che avrà una durata di 3 anni.
- Di: Erika Salvatori
Gli organoidi sono il futuro della ricerca sulle malattie del cervello?
Il dott. Alessandro Fiorenzano è tra i pionieri nella generazione di organoidi cerebrali a partire da cellule staminali pluripotenti per investigare le cause del morbo di Parkinson
Quasi un anno fa avevamo scritto del primo trapianto di cellule nervose derivate da cellule staminali a una persona affetta da Parkinson, procedura portata a termine allo Skåne University Hospital in Svezia. Questo trattamento sperimentale è stato sviluppato all’Università di Lund e ha visto coinvolto uno scienziato italiano: il dottor Alessandro Fiorenzano, attualmente ricercatore presso l’Istituto di Genetica e Biofisica Adriano Buzzati-Traverso (Consiglio Nazionale delle Ricerche, Napoli). Una carriera incentrata sulle cellule staminali, in particolare sul loro utilizzo nella ricerca di terapie cellulari e nello sviluppo di modelli per lo studio delle malattie neurodegenerative. La creazione di strutture tridimensionali, chiamati organoidi, potrebbe rappresentare una svolta agli studi in questo settore.
- Di: Rachele Mazzaracca
Agenda
News da CRISPeR MANIA
a cura di Anna Meldolesi