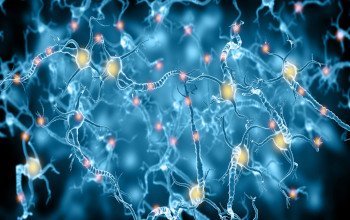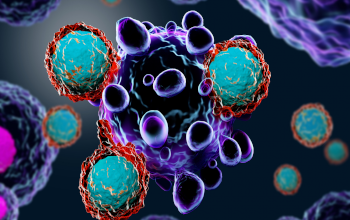News
Terapie su RNA. Una nuova strategia per bloccare la SLA
Il silenziamento genico di SOD1 ha impedito l'insorgenza della SLA in topi presintomatici e ne ha bloccato la progressione in quelli che avevano già sviluppato i primi sintomi
Se il nostro DNA è un enorme “libretto delle istruzioni” per le cellule, che in ogni momento devono attingere da queste informazioni per svolgere le proprie funzioni, basterebbe saltare “un’istruzione” sbagliata per evitare l’insorgere di una malattia causata da un difetto genico. È quello che ha provato a fare un gruppo di ricerca internazionale, guidato da Martin Marsala dell’University of California San Diego School of Medicine, che ha utilizzato una corta molecola di RNA, per silenziare il gene disfunzionale SOD1, causa di una forma genetica di sclerosi laterale amiotrofica (SLA). I test – condotti per ora solo su modelli animali – hanno portato alla prevenzione e al blocco (a seconda dello stadio della malattia) della degenerazione dei neuroni motori.
- Di: Cristina Tognaccini
CAR-T. Dall’India nuovi trattamenti dai costi contenuti
Due aziende indiane stanno mettendo a punto un piano di sviluppo per terapie CAR-T a costi ridotti da impiegare sul mercato interno e, in futuro, su quello mondiale.
Le terapie che sfruttano le CAR-T stanno rapidamente conquistando l’interesse dei ricercatori, che lavorano per produrne versioni sempre più efficienti, precise e sicure, e quello dei pazienti, che finalmente vedono profilarsi nuove speranze per patologie fino a pochi anni fa inarrestabili. Gli enti regolatori di diversi Paesi, tra cui anche l’Italia, hanno già dato l’ok alla commercializzazione di due diversi trattamenti (Kymriah e Yescarta) per garantire ai pazienti con specifiche leucemie, o linfomi, trattamenti di ultimissima generazione. Ma, ancora una volta, il collo di bottiglia è rappresentato dai costi di queste terapie e dalla sostenibilità dei Sistema Sanitario Nazionali di ciascuna nazione.
- Di: Enrico Orzes
Trial clinici in Europa: il fattore limitante è la burocrazia
Il Vecchio Continente è un passo indietro rispetto al Nord America e all’Asia per quanto riguarda il numero di sperimentazioni cliniche con le terapie avanzate
Nel periodo tra il 2014 e il 2018 il numero totale dei trial clinici con le terapie avanzate (Advanced Therapy Medicinal Product, ATMP) è aumentato del 32%, con un incremento notevole in Nord America (+36%, per un totale di 845 studi) e in Asia (+28%, per un totale di 736 studi), ma esiguo in Europa (meno del 2%, per un totale di 323 studi). I dati, provenienti da uno studio condotto dall'Alliance for Regenerative Medicine (ARM), sono stati ricavati dall’analisi di 2.097 studi clinici condotti in tutto il mondo tra il 2014 e la prima metà del 2019. La causa delle differenze nelle percentuali di crescita potrebbe essere proprio la normativa europea, che prevede una gestione più complessa delle revisioni e delle autorizzazioni.
- Di: Rachele Mazzaracca
Cancro al seno: l’intelligenza artificiale batte l’essere umano nella diagnosi
Secondo uno studio recentemente pubblicato su Nature, l’algoritmo riuscirebbe a identificare le lesioni del cancro al seno nelle mammografie meglio dell’occhio umano
I ricercatori della divisione Deep Mind di Google hanno “addestrato” un modello di intelligenza artificiale (AI) a identificare il cancro al seno grazie a migliaia di immagini di mammografie, per poi testare le sue capacità su due set di dati. Lo studio, pubblicato il 1° gennaio 2020 sulla rivista Nature, ha dimostrato che in determinate condizioni l’AI è più efficiente dell’uomo nell’identificazione di lesioni precancerose o indicanti la presenza di cancro al seno. Pur non essendo un sistema infallibile, l’unione tra capacità umane e quelle del programma potrebbe portare a una riduzione degli errori di lettura delle immagini, specialmente per quanto riguarda il rilevamento di falsi positivi e di falsi negativi. I tassi di errore sono ad oggi piuttosto elevati nel caso dello screening mammografico.
- Di: Rachele Mazzaracca
Agenda
News da CRISPeR MANIA
a cura di Anna Meldolesi