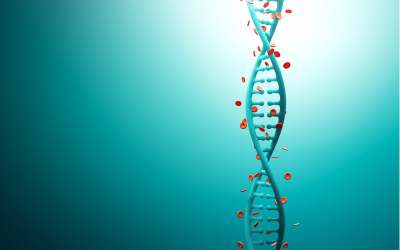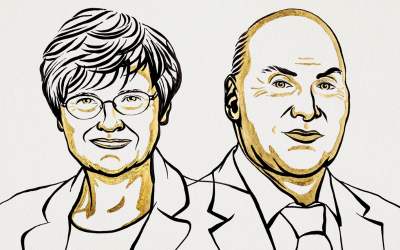News
Editing genomico, cosa funziona meglio per le emoglobinopatie?
L’ormai noto sistema di modifica del DNA potrebbe diventare il trattamento all’avanguardia dell’anemia falciforme e della beta talassemia, ma non tutti gli approcci sono uguali
Un team del St. Jude Children's Research Hospital e del Broad Institute del MIT e di Harvard ha messo a confronto cinque strategie di editing del genoma – utilizzando il più classico Cas9 o il più recente base editing - in cellule staminali ematopoietiche CD34+ e in cellule progenitrici. L’obiettivo è quello di valutare l’induzione della produzione dell’emoglobina fetale (HbF), in grado di sopperire alla mancanza dell’emoglobina che è tipica delle emoglobinopatie. Il base editing è in grado di indurre modifiche più precise e potenti rispetto ad altri approcci di editing, ma è necessario valutarne la sicurezza e l’efficacia. Lo studio è stato pubblicato quest’estate su Nature Genetics.
- Di: Rachele Mazzaracca
Algoritmi e obesità, le previsioni nella chirurgia bariatrica
L’intelligenza artificiale consente di prevedere quale tra l’intervento di bypass gastrico e di sleeve gastrectomy sia la scelta opportuna, sapendo in anticipo quanti chili può perdere la persona
Lo scorso 30 agosto a Napoli è iniziato il congresso mondiale dell'International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders (IFSO), durante il quale è stato presentato il lavoro del gruppo di ricerca dell’Università di Lille (Francia), sostenuto dal progetto SOPHIA dell’Unione Europe e coordinato dalla University College of Dublino. Il team ha sviluppato un algoritmo che, grazie ai dati di quasi diecimila pazienti provenienti da otto diversi Paesi, consentirebbe di prevedere se il ricorso alla chirurgia bariatrica sia la scelta più appropriata per il paziente. Lo studio è stato pubblicato su The Lancet Digital Health.
- Di: Rachele Mazzaracca, Eugenio Santoro (Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS)
Distrofie muscolari dei cingoli: a che punto è la terapia genica?
Prof. Yvàn Torrente (Milano): “Sono in via di sviluppo due strategie terapeutiche dalla diversa tecnologia partendo dal medesimo quesito iniziale: come restituire al muscolo la proteina mancante?”
Al culmine della scorsa estate la notizia dell’avvio di uno studio clinico con una nuova terapia genica destinata al trattamento di una distrofia muscolare dei cingoli è passata sotto relativo silenzio. Il fatto che non sia stata pubblicata la lista dei centri ospedalieri presso cui saranno trattati i pazienti e che la prima somministrazione non sarà eseguita prima di gennaio 2024 non ha contribuito alla diffusione della notizia che, invece, è estremamente significativa nel contesto della ricerca di nuove opzioni di cura per le distrofie dei cingoli. Queste malattie, infatti, continuano a rappresentare un vasto ed eterogeneo insieme di patologie neuromuscolari orfane di trattamenti. Ne abbiamo parlato con il professor Yvàn Torrente, neurologo presso la Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e Direttore della Struttura Semplice di Terapie Cellulari e Geniche del Policlinico di Milano.
- Di: Enrico Orzes
Il Nobel premia la scienza dietro ai vaccini per COVID-19
Da un’idea che non trovava finanziamenti al maggior riconoscimento scientifico: Karikò e Weissman hanno contribuito a creare una delle più grandi innovazioni medico-scientifiche degli ultimi anni
La storia dei vaccini a mRNA comincia più di 30 anni fa: un inizio travagliato, con pochi soldi ed esperimenti con scarsi risultati. In molti hanno abbandonato, o si sono visti costretti a farlo per la mancanza di finanziamenti, ma qualcuno ha creduto nel potenziale di trasformare l’mRNA in un farmaco a dispetto delle difficoltà economiche. La biochimica Katalin Karikó e l’immunologo Drew Weissman hanno così iniziato a collaborare negli anni ’90 per sviluppare un vaccino a mRNA per l’HIV, virus che stava causando un elevato numero di vittime e allora senza speranze di terapie. Da allora la ricerca ha fatto passi da gigante, trasformando una ricerca che all’inizio dava alcuni problemi a livello immunitario in un alleato indispensabile per la lotta all’infezione che nel 2020 ha fermato il mondo.
- Di: Rachele Mazzaracca
Agenda
News da CRISPeR MANIA
a cura di Anna Meldolesi