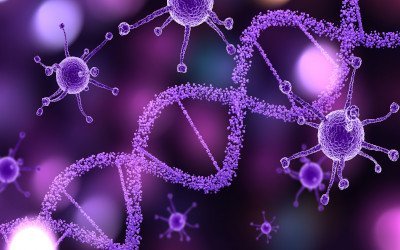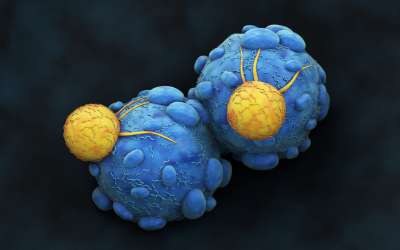News
Terapie avanzate per la sindrome di Rett
In Nord America sono in corso due studi clinici di Fase I/II con approcci di terapia genica, in Europa è stato avviato un progetto basato sull’editing genomico e coordinato dall’Università di Siena
Nel vasto insieme dei disturbi dello sviluppo neurologico la sindrome di Rett rappresenta per la medicina una delle sfide più ostiche da superare, dal momento che il gene MECP2, coinvolto nella genesi della patologia, è al crocevia di una rete di percorsi neuronali essenziali per il corretto sviluppo delle funzionalità sinaptiche. Non sono stati ancora approvati farmaci in grado di trattare le cause all’origine della malattia ma da ricerche recenti sono scaturiti due filoni di studio che, nel prossimo futuro, potrebbero cambiare le cose: da una parte la terapia genica per gene replacement e dall’altra la strategia di editing genomico stanno permettendo di compiere solidi passi avanti nella ricerca di una terapia efficace. Lo spiegano nel dettaglio le professoresse Alessandra Renieri e Ilaria Meloni, dell’Università degli Studi di Siena.
- Di: Enrico Orzes
Un nuovo protagonista sulla scena delle terapie avanzate
AstraZeneca acquista da Pfizer un pacchetto da un miliardo di dollari in programmi di terapia genica e prepara il suo ingresso nell’universo delle ATMP
Le relazioni economiche che si instaurano tra aziende operanti in un dato settore - farmaceutico, immobiliare, automobilistico o di altro genere - somigliano su larga scala a quelle che regolano le interazioni fisiologiche tra le varie cellule dell’organismo. Nella loro ciclicità garantiscono la sopravvivenza. Così, la discesa sul campo delle terapie avanzate di AstraZeneca permetterà di spingere avanti lo sviluppo di molecole promettenti e allargare il panorama delle aziende presenti in un settore che sta rivoluzionando la medicina. Si tratta di uno dei passi più importanti mai compiuti dal colosso farmaceutico britannico che ha raggiunto un accordo con Pfizer per l’acquisizione di un pacchetto di programmi di terapia genica in fase iniziale.
- Di: Enrico Orzes
Terapia genica per l’alcolismo: i primi dati sulle scimmie
Di recente questa notizia è rimbalzata su diverse testate giornalistiche, destando grande interesse, ma è fondamentale essere consapevoli che non si tratta di una cura per l’alcolismo
Una terapia genica in fase di valutazione per il trattamento del morbo di Parkinson potrebbe ridurre il consumo di alcolici nei casi più gravi: il trattamento, testato su primati non umani, avrebbe l’obiettivo di ripristinare la via di sintesi della dopamina nel cervello. Lo studio, condotto dai ricercatori della Oregon Health & Science University (Stati Uniti) e pubblicato ad agosto su Nature Medicine, ha dimostrato che il trasporto del gene che codifica per il fattore neurotrofico derivato dalla linea cellulare gliale umano (hGDNF) in un'area specifica del cervello degli esemplari di scimmia - con forte dipendenza da alcolici - ha portato a una drastica riduzione del loro consumo di alcol. Si tratta di dati preliminari, che hanno fatto molto parlare ma che restano molto lontani dall’applicazione sull’essere umano.
- Di: Rachele Mazzaracca
Al via uno studio clinico su una CAR-T allogenica “con interruttore di sicurezza”
Grazie alla tecnologia CRISPR è stata messa a punto una versione dei linfociti T ingegnerizzati in grado di spegnere - in presenza di certi stimoli - la propria attività terapeutica
È prodotta a partire da materiale biologico messo a disposizione da donatori - quindi non personalizzata per un unico paziente ma applicabile a molti e pronte all’uso (“off-the-shelf”) - ed equipaggiata con una tecnologia che, in caso di eventi collaterali inattesi, può neutralizzarne l’effetto, azzerando così il rischio di conseguenze gravi. Si tratta dell’ultima versione delle CAR-T a cui l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha recentemente concesso l’autorizzazione all’avvio di uno studio clinico di Fase I rivolto a pazienti affetti da leucemia mieloide acuta (AML), una patologia del sangue particolarmente aggressiva che colpisce soprattutto le fasce più anziane della popolazione.
- Di: Enrico Orzes
Agenda
News da CRISPeR MANIA
a cura di Anna Meldolesi