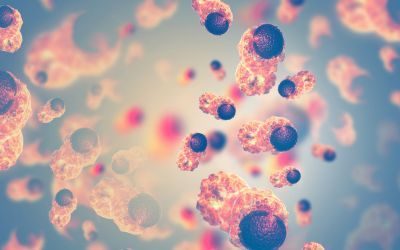News
Migliorare la ricerca sulle cellule staminali
Una pubblicazione, frutto di una collaborazione internazionale, in cui si delineano degli standard per l’uso delle staminali umane: il nuovo lavoro dell’ISSCR è consultabile online
L’International Society for Stem Cell Research (ISSCR) ha recentemente diffuso un documento sugli standard da rispettare nella ricerca che prevede l’utilizzo di cellule staminali. Il fine di questa iniziativa, frutto di una collaborazione internazionale, è quello di migliorare il rigore nella ricerca preclinica, la riproducibilità degli esperimenti e, di conseguenza, aumentare il numero di terapie che proseguono nel percorso che le porta dal laboratorio al paziente. Il documento è solo l’ultimo condiviso dall’ISSCR: società internazionale di elevata reputazione nel settore, ne aveva già prodotti altri in precedenza, tra cui le Linee Guida per la ricerca sulle staminali, aggiornate nel 2021.
- Di: Rachele Mazzaracca
Sperimentare sugli embrioni: normativa e scienza vanno a velocità diverse
Lo sviluppo scientifico della “scienza degli embrioni” procede veloce e la sua regolamentazione deve trovare il modo di tenere il passo. Quali saranno le regole?
Alla fine del 2018 He Jiankui ha gettato un’ombra sul mondo scientifico dichiarando di aver modificato con CRISPR i genomi di tre embrioni umani con l'obiettivo di renderli resistenti all'infezione da HIV. Tre bambini in carne e ossa, i primi in cui un gene è stato ritoccato dalle ormai famose forbici molecolari, che sono costati al ricercatore cinese altrettanti anni di carcere per aver violato la legge, oltre a essere stato aspramente criticato dalla comunità scientifica. Da allora si sono susseguiti eventi e scoperte che hanno contribuito a far avanzare il settore, ma le autorità regolatorie fanno fatica a muoversi alla stessa velocità della ricerca. Un articolo pubblicato a maggio su Nature ha affrontato la questione: assicurarsi che la scienza sia regolamentata in modo tempestivo ed efficace significa mantenere un solido contratto sociale tra scienza e società.
- Di: Rachele Mazzaracca
Nanoparticelle lipidiche per trasportare CRISPR nei polmoni
L’obiettivo è correggere la mutazione nel gene che causa la fibrosi cistica e altre patologie polmonari, veicolando nelle cellule l’RNA messaggero che codifica per il sistema CRISPR
Oggi abbiamo la fortuna di poter modificare singole lettere nell’alfabeto del genoma per correggere gli errori alla base delle malattie genetiche. Dobbiamo però ancora imparare a veicolare questi “bisturi molecolari” negli organi bersaglio con un metodo sicuro e ripetibile nel tempo. I vettori virali sono i più usati per il trasporto dei geni, ma hanno ancora diversi limiti di sicurezza ed efficacia che spingono il mondo della ricerca a proporre nuove alternative. Gli ingegneri del Massachusetts Institute of Technology (MIT) hanno messo a punto delle nanoparticelle lipidiche per veicolare il sistema di editing Crispr-Cas9 sotto forma di RNA messaggero nei polmoni, per cui non esistono ancora strategie di trasporto efficaci. I risultati sono stati pubblicati a fine marzo su Nature Biotechnology.
- Di: Erika Salvatori
CAR-T ad attivazione magnetica contro i tumori solidi
In uno studio dell’Accademia Cinese delle Scienze, pubblicato sulla rivista Advanced Materials, è descritta una futuristica versione robotica di cellule CAR-T
Difficile dire se sia più avveniristico il concetto di uno “sciame” di cellule CAR-T robotizzate che va all’attacco della massa tumorale, distruggendola, o quello di un sistema ad attivazione magnetico-acustica utilizzato per innescare tali cellule, permettendo loro di aggredire quelle cancerose. C’è un pizzico di follia e genialità in entrambe queste idee illustrate in un articolo pubblicato sulla rivista Advanced Materials da un gruppo di ricercatori dell’Accademia Cinese delle Scienze. Guidati dal prof. Cai Lintao, dell’Istituto di Tecnologia Avanzata di Shenzhen (SIAT), essi hanno progettato un prototipo di microrobot il quale, sfruttando le cellule CAR-T, è in grado di navigare all’interno del flusso sanguigno e dirigersi verso il microambiente tumorale. Qui, dopo esser stato attivato, può superare le difese del tumore e distruggerlo.
- Di: Enrico Orzes
Agenda
News da CRISPeR MANIA
a cura di Anna Meldolesi