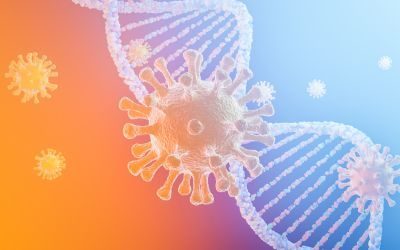News
Terapie avanzate per la Duchenne: un addio e qualche timida speranza
La morte del paziente pioniere Terry Horgan è un monito sui rischi dei vettori virali ma l’attenzione ora è puntata sulla prima terapia genica in approvazione negli Stati Uniti
Sulla difficile frontiera delle terapie avanzate ogni decesso è un dolore da cui si deve imparare tutto il possibile. L’esito infausto del trattamento individuale per la distrofia muscolare di Duchenne messo a punto dalla no-profit Cure Rare Disease per Terry Horgan, e sperimentato unicamente su questo ragazzo americano, può insegnare poco sulle specificità di CRISPR. Il decesso infatti è avvenuto prima che la macchina molecolare dell’editing potesse entrare in azione. Ma le informazioni sul caso, diffuse a maggio su un archivio di preprint in attesa di una pubblicazione classica con revisione dei pari, rappresentano lo stesso un contributo prezioso per l’avanzamento delle conoscenze in un settore in cui la scienza non ha intenzione di arrendersi.
- Di: Anna Meldolesi
Terapia genica per la Batten, a che punto siamo?
Il motto della giornata mondiale 2023 riguarda proprio la cura: #Battenadvocatesforacure. Sono diversi gli studi in corso sulla terapia genica, ma si tratta ancora di sperimentazioni in fase iniziale
Il 9 giugno è la giornata mondiale per la malattia di Batten (#BattenDay2023), nome che racchiude un ampio ed eterogeneo gruppo di malattie neurodegenerative rare di origine genetica, note anche come ceroidolipofuscinosi neuronali (CLN). Sebbene sia stata descritta all’inizio del secolo scorso da Frederik Batten, solo nel 1995 sono stati identificati i primi geni correlati alla malattia. Da allora sono oltre una decina le forme di patologia che sono state classificate, da CLN1 a CLN14. Purtroppo, non esiste una cura per la Batten e i trattamenti attualmente disponibili si basano sulla gestione dei sintomi. La terapia genica è un approccio terapeutico in fase iniziale di ricerca, ma sono diversi gli studi clinici che intendono esplorare concretamente questa possibilità.
- Di: Rachele Mazzaracca
Terapie di precisione per le malattie genetiche rare: un obiettivo possibile?
Le riflessioni sulle applicazioni delle terapie di precisione sono molteplici e spaziano dalla fattibilità scientifica al tema, molto sentito, dell’accesso
Sequenziare, analizzare, comparare, trovare il gene difettoso, studiarlo e pensare a come correggere l’errore: riuscire a comprendere le basi genetiche di una malattia è una vera e propria sfida, ma grazie ai progressi tecnico-scientifici fatti negli ultimi decenni è ora più semplice, veloce e meno costoso. Il rovescio della medaglia è l’accessibilità, perché riuscire ad avere a disposizione una terapia di precisione – sia essa di terapia genica, editing genomico o una terapia su RNA – che sia in primis efficace e sicura, ma anche disponibile precocemente e in modo equo per tutti coloro che ne hanno bisogno non è per niente facile. A fine gennaio è stato pubblicato un articolo sul tema, il cui contenuto riflette le discussioni di un workshop tenutosi nel giugno 2021 dal titolo "Gene-Targeted Therapies: Early Diagnosis and Equitable Delivery" (National Institutes of Health, 2021).
- Di: Rachele Mazzaracca
Editing dell’RNA: nel tessuto vascolare regola l’infiammazione
L’enzima ADAR contribuisce al reclutamento delle cellule immunitarie nel sito di una lesione ischemica e potrebbe essere il bersaglio di nuove terapie contro le malattie infiammatorie
Si dice che l’ambasciator non porta pena, ma nel caso dell’RNA messaggero può fare molti danni: un errore nella sua sequenza può produrre una proteina anomala o difettosa. Alcuni enzimi hanno la capacità di “riscrivere” le istruzioni per la sintesi delle proteine contenute nelle molecole di RNA, senza modificare in modo permanente il genoma. I ricercatori dell’Università di Newcastle hanno scoperto che in caso di lesioni ischemiche, uno di questi enzimi - chiamato ADAR2 - recluta le cellule immunitarie dal circolo sanguigno e attiva dei meccanismi infiammatori che possono cronicizzare e danneggiare i tessuti. I risultati, pubblicati su Immunity, propongono ADAR2 come un potenziale bersaglio terapeutico per varie malattie infiammatorie, come l’infarto, il cancro o le malattie autoimmuni.
- Di: Erika Salvatori
Agenda
News da CRISPeR MANIA
a cura di Anna Meldolesi