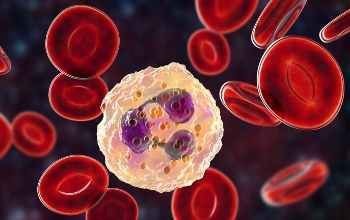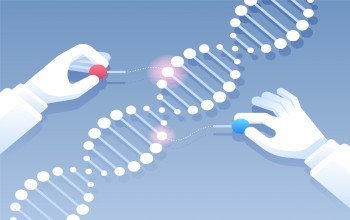News
Terapia genica: una nuova via per la malattia granulomatosa cronica
Il primo trial è stato effettuato su 9 pazienti tra Stati Uniti e Regno Unito. I risultati preliminari indicano l’efficacia della terapia sulla forma X-linked di questa immunodeficienza primitiva rara
La malattia granulomatosa cronica (CGD) è una immunodeficienza primitiva rara (1 caso su 217.000 nati a livello mondiale), caratterizzata da suscettibilità alle infezioni da parte di funghi e batteri e dalla presenza di granulomi, cioè ammassi di tessuto infiammato, in tutto il corpo. Infatti, in questo caso i neutrofili, un tipo di globuli bianchi, non sono in grado di rispondere agli agenti estranei e svolgere la loro attività difensiva. Un recente studio pubblicato su Nature Medicine analizza i risultati preliminari della terapia genica su nove pazienti affetti CGD legata al cromosoma X, forma che colpisce il 65% dei pazienti in Nord America e Europa Occidentale e che è causata da mutazione sul gene CYBB. Si tratta del primo studio clinico con terapia genica per CGD e i risultati sono promettenti.
- Di: Rachele Mazzaracca
Zanzare “all-male”, la nuova strategia genetica contro la malaria
La malattia che flagella l’Africa potrebbe essere sconfitta alterando con un “gene drive” basato su CRISPR il rapporto numerico tra i sessi degli insetti vettori
Il nome di Andrea Crisanti è noto ai più per il caso studio di Vo’ Euganeo e per la strategia di sorveglianza attiva che sta aiutando il Veneto ad arginare l’epidemia di COVID-19. Ma il medico romano è anche il pioniere di una tecnologia di frontiera per il controllo della malaria: il "gene drive". L’idea, sviluppata con il suo gruppo di ricerca dell’Imperial College di Londra e pubblicata l’11 maggio su Nature Biotechnology, consiste nel modificare le zanzare che trasmettono il plasmodio della malaria, appartenenti alla specie Anopheles gambiae, in modo tale da far nascere solo gli esemplari del sesso che non punge. Non essendoci abbastanza femmine per sostenere la riproduzione, le popolazioni di insetti vettori collasserebbero e si fermerebbe la trasmissione della malattia.
- Di: Anna Meldolesi
Cellule staminali: il gene che mantiene la pluripotenza
La scoperta arriva da un gruppo di ricerca padovano e contribuirà ad allargare il campo di studio delle cellule staminali umane. Ne parliamo con il prof. Graziano Martello che ha guidato lo studio.
Alla presentazione di un prototipo di Formula 1 vincente tutti rimangono a bocca aperta di fronte al prodotto finale, spesso incapaci di comprendere che l’autentica rivoluzione sul piano tecnico giace sotto una carrozzeria fiammante. Un concetto che serve a dimostrare la centralità della ricerca di base in ogni campo del sapere umano dall’ingegneria alla biologia: ecco perché la scoperta di un gene che permetta di “conservare” la pluripotenza delle cellule staminali può spalancare porte finora rimaste sprangate nella ricerca di nuovi trattamenti per patologie ancora senza risposta. Lo studio è stato pubblicato il 12 maggio su Nature Communications e porta la firma del prof. Graziano Martello, del Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Padova, che ci racconta la sua ricerca.
- Di: Enrico Orzes
Cellule T modificate con CRISPR contro il tumore polmonare
Uno studio clinico, svolto in Cina, ha verificato la sicurezza di questo innovativo approccio di immunoterapia che potrebbe portare a un miglior controllo della malattia.
Modificare le cellule del sistema immunitario per renderle più forti contro i tumori, è una delle strategie più sfruttate negli ultimi decenni in oncologia. Ne sono un esempio le terapie CAR-T e l’immunoterapia basata sull’inibizione dei “checkpoint immunitari”, una sorta di “freno”, che quando attivato dal tumore paralizza le cellule T impedendogli di svolgere la loro funzione di difesa. Oggi l’immunoterapia sfrutta anticorpi per disinnescare questi freni. Un’altra soluzione è utilizzare sistemi di editing genomico, come CRISPR, per eliminare direttamente i checkpoint immunitari dalle cellule T. È quello che hanno testato i ricercatori della West China Hospital of Sichuan University, in Cina, in un trial clinico su un gruppo di pazienti con tumore polmonare metastatico non a piccole cellule.
- Di: Cristina Tognaccini
Agenda
News da CRISPeR MANIA
a cura di Anna Meldolesi