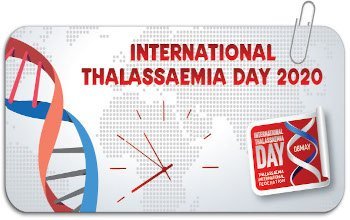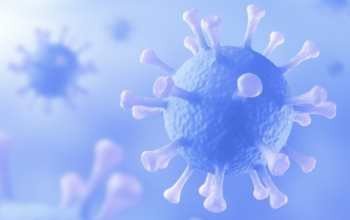News
Brevetti e proprietà intellettuale al tempo del Coronavirus
Il libero accesso alle proprietà intellettuali potrebbe garantire ai cittadini del mondo di accedere a prezzi ragionevoli alle terapie e alle tecniche di diagnostica per SARS-CoV-2
Una delle questioni in fase di discussione in questo complicato periodo di emergenza sanitaria riguarda i regimi di proprietà intellettuale. Diversi Paesi, organizzazioni e singoli chiedono che le proprietà intellettuali siano un sostegno, e non un ostacolo, per lo sviluppo di farmaci, tecniche diagnostiche e vaccini per il virus SARS-CoV-2. La richiesta è che venga consentito il libero accesso ai brevetti o la concessione di licenze a condizioni ragionevoli e convenienti per qualsiasi farmaco, terapia avanzata, vaccino o tecnica diagnostica per combattere la pandemia. Tutto questo per garantire ai cittadini del mondo l’equità di trattamento. Un progetto con il coinvolgimento di enti, aziende e istituzioni a livello globale potrebbe essere la soluzione?
- Di: Rachele Mazzaracca
Le terapie avanzate stanno rivoluzionando la cura della talassemia
Nella Giornata Internazionale della Talassemia ripercorriamo la ricerca di una cura, in continua evoluzione, dalla terapia genica all’editing genomico
Si può sempre fare di meglio. Soprattutto in campo scientifico dove l’innovazione e la ricerca continua possono non solo trovare terapie per malattie prima incurabili, ma anche spingersi oltre, perfezionandole ulteriormente. È il caso della beta-talassemia – ricordata l’8 maggio di ogni anno con la International Thalassaemia Day – una malattia genetica tipica del bacino del Mediterraneo e dell’Asia, per cui neanche un anno fa è stata approvata in Europa la prima terapia genica, oggi disponibile in Germania e in procinto di arrivare anche in altri Paesi, tra cui l’Italia. Un traguardo che non ha fermato la ricerca, che continua ad avanzare testando strategie sempre più innovative – come l’editing genomico – che potrebbero andare ad aggiungersi alla terapia genica.
- Di: Cristina Tognaccini
Le terapie avanzate che fanno battere il cuore
In corso un trial per valutare una terapia genica per una malattia rara cardiaca, mentre prosegue la comprensione del funzionamento della terapia cellulare sul cuore infartuato
Le terapie avanzate appaiono all’orizzonte anche delle patologie cardiache. Una delle prime che potrebbe beneficiarne è la malattia di Danon, una condizione molto rara e fatale causata dalla mutazione del gene LAMP2, per cui un gruppo di ricercatori dell’University of California, San Diego School of Medicine, negli USA, ha testato una terapia genica in modelli murini. I risultati promettenti hanno aperto le porte a uno studio clinico. Nel frattempo, proseguono anche le ricerche sulle cellule staminali, campo in cui un gruppo di ricercatori della Mayo Clinic a Rochester, sempre negli USA, ha compreso i meccanismi con cui le cellule staminali possono riparare il cuore dopo un infarto. Fornendo un modello – testato su modelli animali – del loro funzionamento.
- Di: Cristina Tognaccini
Donne a caccia di Coronavirus
Dal microscopio elettronico alle caverne, dalla scoperta del primo Coronavirus alla ricerca di possibili nuove zoonosi: le storie di June Almeida e Shi Zhengli
Prima dell’epidemia di SARS del 2003 si sapeva poco dei Coronavirus (CoV), i quali venivano normalmente associati ai comuni raffreddori. Con la prima grande epidemia del XXI secolo, la prospettiva è cambiata. Per la prima volta abbiamo assistito alla diffusione di un CoV dal potenziale pandemico, allora fortunatamente superato. Purtroppo, non è andata allo stesso modo con il SARS-CoV-2, responsabile della pandemia di COVID-19 in corso. I Coronavirus sono infatti conosciuti solo dal 1964, anno in cui June Almeda ha identificato un Coronavirus per la prima volta grazie a una tecnica pionieristica di microscopia. Coincidenza vuole che il 1964 sia l’anno di nascita della virologa cinese Shi Zheng-Li, soprannominata “Bat woman”, che esplora grotte e caverne, studiando virus potenzialmente mortali per l’uomo.
- Di: Rachele Mazzaracca
Agenda
News da CRISPeR MANIA
a cura di Anna Meldolesi