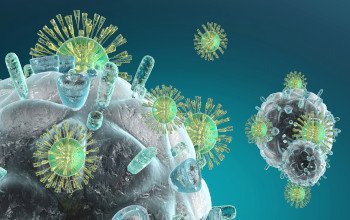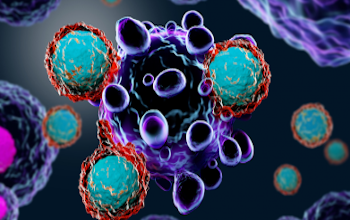News
Terapie cellulari non approvate: l’allarme dell’EMA
Speranze e promesse nascondono disinformazione, truffe ed effetti collaterali: l’European Medicines Agency mette in guardia i pazienti contro l’uso di terapie cellulari non approvate
Le possibilità offerte dalle terapie cellulari sono da decenni oggetto di studio della comunità scientifica internazionale e sono una grande promessa per una serie di gravi patologie ad oggi incurabili. Da un lato, il trapianto di midollo osseo, quello di epidermide per i grandi ustionati e le trasfusioni, approvate sulla base di fondamenti scientifici ed etici, sono un esempio fruttuoso delle opportunità offerte dalla pratica medica riconosciuta; dall’altro, una vasta gamma di prodotti cellulari e tessuti non regolamentati, procedure mediche eseguite senza il supporto di evidenze scientifiche e indicazioni di efficacia e sicurezza attraggono pazienti spesso ignari della situazione. Per questo motivo, a seguito della raccomandazione del Comitato per le Terapia Avanzate (CAT), l’European Medicines Agency (EMA) ha messo in guardia i pazienti contro l'uso di terapie cellulari non approvate e non regolamentate.
- Di: Rachele Mazzaracca
COVID-19 e immunità. Ciò che sappiamo e ciò che ancora dobbiamo scoprire
La settimana dell’Immunizzazione, in corso dal 24 al 30 aprile e promossa dall’OMS, è l’occasione per capire come il nostro sistema immunitario risponde a SARS-CoV-2 e, più in generale, ai patogeni
La migliore chiave di interpretazione della prima fase della pandemia del virus SARS-CoV-2 è quella della “rapidità” riscontrata nell’impennata improvvisa e inarrestabile dei contagiati e nell’urgenza di una risposta medica adeguata a qualcosa che ancora non si conosce, nell’obbligatorietà di un intervento istituzionale deciso e nel brusco cambio di stile di vita che in pochi giorni ha recluso la popolazione all’interno delle proprie abitazioni. Ora le curve epidemiche sembrano appiattirsi e si pensa a come ritornare nei ranghi di un’esistenza il più possibile normale, perciò il filo rosso della cosiddetta “fase due” - e di quelle che la seguiranno - non può che essere il concetto di “immunizzazione".
- Di: Enrico Orzes
CAR-T contro il linfoma mantellare
Uno studio pubblicato su The New England Journal of Medicine conferma che le cellule CAR-T possono costituire una valida opzione per i pazienti con il tumore in forma recidivante o resistente
La terapia perfetta non esiste, specialmente in Oncologia. È un concetto molto duro da accettare ma corrisponde alla verità perché nella lotta contro il cancro nulla funziona completamente: quello che, tuttavia, permette di guardare al futuro con ottimismo è la trasversalità d’applicazione che trova un ottimo esempio nelle terapie a base di cellule CAR-T già approvate contro il linfoma diffuso a grandi cellule B, in sperimentazione contro il linfoma follicolare e ora promettenti anche contro il linfoma mantellare.
- Di: Enrico Orzes
CRISPR diagnostico: può rilevare infezioni e rigetto post-trapianto
Dopo un trapianto, i pazienti sono più sensibili alle infezioni e il rischio di rigetto è sempre dietro l’angolo. Il sistema di editing genomico CRISPR potrebbe essere d’aiuto per analisi e diagnosi.
Nel trapianto di organi, le infezioni e il rigetto sono i rischi principali. Per diagnosticarli in tempi brevi e migliorare i risultati a lungo termine sono necessarie strategie innovative, efficienti, veloci e poco costose. CRISPR può rilevare DNA e RNA in diverse tipologie di campione con un’ottima sensibilità e specificità, rendendolo uno dei test possibili al “Point Of Care” (POC), cioè utilizzabile “presso il punto di assistenza” (ad esempio direttamente a casa del paziente). In questo caso è stata sperimentata la tecnica SHERLOCK, basata su Crispr-Cas13a, per la diagnosi precoce di infezioni e rigetto in pazienti che erano stati sottoposti a trapianto renale.
- Di: Rachele Mazzaracca
Agenda
News da CRISPeR MANIA
a cura di Anna Meldolesi