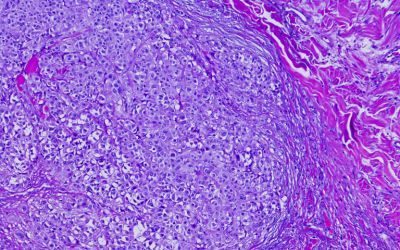News
Terapia cellulare: cellule B geneticamente ingegnerizzate per la MPS I
La terapia sperimentale è ideata per produrre l’alfa-L-iduronidasi (IDUA), enzima mancante nei pazienti con mucopolisaccaridosi di tipo 1, ed è in valutazione con uno studio clinico di Fase I
La cellula è la struttura di base della vita. L’affermazione di tale concetto ha permesso agli studiosi di biologia cellulare e molecolare di compiere balzi da gigante nella comprensione degli organismi giungendo a padroneggiare le tecniche di manipolazione degli stessi. Così l’ingegneria genetica ha fatto da locomotrice agli studi sulla cellula portando alla nascita di terapie cellulari come quelle messe a punto dalla biotech statunitense Immusoft, che ha l’obiettivo di trasformare le cellule immunitarie in piccole “biofabbriche” in grado di sfornare molecole ed enzimi terapeutici. In questo senso la cellula diventa essa stessa la terapia per malattie causate dalla carenza o dall’assenza di specifiche proteine. Ora questa strategia approda per la prima volta alla sperimentazione clinica: l’obiettivo è la mucopolisaccaridosi di tipo I (MPS I).
- Di: Enrico Orzes
mRNA: in arrivo un vaccino per il melanoma?
Risultati promettenti arrivano da uno studio clinico basato sulla combo immunoterapia e vaccino terapeutico a mRNA. Tre giorni fa trattato anche il primo paziente italiano
Di mRNA si è parlato tanto in relazione a SARS-CoV-2 ma, superato il momento della pandemia, si sono aperte altre strade. Una tra tutte è quella della lotta contro il cancro (di cui abbiamo parlato qui), ma l’accelerazione in questo campo potrebbe portare benefici anche nel trattamento delle malattie cardiovascolari e autoimmuni. Una delle aziende più forti nel settore è Moderna Therapeutics, già nota per aver sviluppato e commercializzato uno dei primi vaccini a mRNA utilizzati contro l’infezione da COVID-19. Stando alle dichiarazioni fatte dall’azienda negli ultimi mesi, l’obiettivo è di commercializzare questi vaccini entro il 2030. Lo scorso dicembre è stato annunciato che il vaccino a mRNA, associato all’immunoterapico pembrolizumab, dimezzerebbe il rischio di recidiva e morte a 3 anni dall’intervento di rimozione chirurgica del melanoma in stadio avanzato.
- Di: Rachele Mazzaracca
Tecnologia mRNA, la corsa verso una terapia per il cancro
Vaccini antitumorali, citochine per l'immunoterapia, soppressori tumorali, cellule T ingegnerizzate e editing genomico: le terapie a base di mRNA potrebbero trovare applicazione in oncologia
Una review pubblicata ad agosto 2023 su Nature Reviews Cancer offre una panoramica degli approcci che si basano sull’utilizzo dell’RNA messaggero che sono oggi in fase di studio per trovare possibili utilizzi in ambito oncologico. Sebbene l’mRNA non sia stato inizialmente destinato a scopi terapeutici, in primis per le sue caratteristiche biologiche che lo rendono difficile da gestire, negli anni è stato rivalutato e oggi è uno dei settori della ricerca in cui si investe di più. Grazie alla perseveranza di chi ha creduto nelle potenzialità di questa molecola fin dall’inizio, è stata spianata la strada verso le applicazioni terapeutiche e il cancro è diventato uno dei target per eccellenza.
- Di: Rachele Mazzaracca
Luigi Naldini vince il Phacilitate Lifetime Achievement Award 2024
Il riconoscimento alla carriera al direttore dell’Istituto San Raffaele-Telethon per la terapia genica (SR-Tiget) di Milano per lo sviluppo di vettori virali utilizzati nelle terapie geniche
Una carriera dedicata alla ricerca sui vettori lentivirali premiata con il Phacilitate Lifetime Achievement Award 2024: Luigi Naldini - direttore dell’Istituto San Raffaele-Telethon per la terapia genica (SR-Tiget) di Milano, professore ordinario di Istologia e di Terapia Genica e Cellulare presso l’Università Vita-Salute San Raffaele e membro del Comitato Scientifico di Osservatorio Terapie Avanzate – ha ricevuto il riconoscimento lo scorso 18 gennaio a Miami, in occasione della Phacilitate's Advanced Therapies Week 2024. Il premio è frutto del ruolo determinante che lo scienziato ha avuto nello sviluppo di innovative terapie per malattie genetiche, e non solo, grazie agli studi sui vettori virali oggi utilizzati anche in clinica.
- Di: Redazione
Agenda
News da CRISPeR MANIA
a cura di Anna Meldolesi